Principi di progettazione tecnologica ambientale
01QMGPM
A.A. 2018/19
Lingua dell'insegnamento
Italiano
Corsi di studio
Corso di Laurea in Architettura - Torino
Organizzazione dell'insegnamento
| Didattica | Ore |
|---|---|
| Lezioni | 60 |
Docenti
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazzotta Alessandro | Ricercatore | CEAR-08/C | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Collaboratori
Didattica
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|
| ICAR/12 | 6 | C - Affini o integrative | A13 |
2018/19
Obiettivo del corso è l’acquisizione di una prima consapevolezza critica a riguardo dei riferimenti culturali e del repertorio di tecniche e strumenti metodologici inerenti la Progettazione Tecnologica Ambientale, paradigma semantico consolidatosi a seguito dell’evoluzione del linguaggio disciplinare della Tecnologia dell’Architettura, allo scopo di meglio evidenziare il fondamentale ruolo di approcci, metodi e tecniche eco-oriented nella complessificata articolazione concettuale che il progetto dello spazio costruito ha assunto nella contemporaneità.
Attraverso i contenuti erogati, lo studente - prossimo a concludere il percorso di studi triennale - si costruisce un orizzonte di riferimento, sia dal punto di vista della conoscenza sintetica della riflessione teorica relativa ai temi di discussione più attuali, sia in relazione a una prima padronanza operativa (nell’ottica di una analisi qualitativa) dei principi base relativi alle specifiche metodologie e soluzioni tecniche a disposizione.
In coerenza con l’approccio caratterizzante la tradizione dell’insegnamento dell’Architettura al Politecnico di Torino, particolare attenzione è attribuita alla esplicitazione dei contenuti nella relazione di significato tra linguaggi architettonici, tecniche, identità fisica e culturale dei luoghi: il rapporto tecnica/forma è indagato, da questo punto di vista, secondo uno sguardo coerente alle varie scale del progetto e attento al rapporto tra tradizione e innovazione.
The Educational Goal of the course is the comprehension of a first critical approach on the conceptual and operational tools related to the Environmental Technology Design: in Italy, this semantic paradigm has recently been consolidated in academic curricula because the evolution of the discipline of Architectural Technology, in order to emphasize the fundamental role of approaches, methods and eco-oriented techniques in the complexity frame that characterize contemporary built environment design.
The course contents give students, in their final year degree path, the opportunity to learn a reference horizon of the basic principles and methodologies, both from the point of view of synthetic knowledge of theoretical reflection on the themes of discussion, both in relation to a first ability in approaching the eco-oriented architectural project, from a qualitative point of view.
In keeping with the approach that characterize the tradition of teaching Architecture at the Politechnic of Turin, particular attention is given to the identity of places: the ratio technique/form is investigated from this perspective, according to a comprehensive method at the different scales of the project and with attention on the relationship between tradition and innovation.
Lo studente acquisisce conoscenze a riguardo dei fondamenti che caratterizzano l’area di apprendimento coperta dal modulo di insegnamento, con particolare riferimento a
- FATTI: l’esigenza di caratterizzare il paesaggio costruito nei termini di spazio ambientalmente sostenibile determina la necessità di utilizzare tecnologie e dispositivi spaziali per il controllo della qualità ambientale e dell’efficienza energetica, attraverso un approccio transcalare (dalla scala microurbana alle soluzioni di involucro, nel rapporto tra costruito e spazio aperto) e olistico (l’interpretazione dei vari temi nella loro reciprocità);
- PRINCIPI: è opinione ormai condivisa che le tecniche per la sostenibilità ambientale del costruito debbano essere interpretate anche in relazione agli esiti di linguaggio architettonico, oltre che di performance prestazionali;
- TEORIE: la complessità metodologica dell’approccio al costruito sostenibile è deducibile dalla sovrapposizione concettuale dei diversi paradigmi di riferimento elaborati al riguardo;
- PRATICHE: è possibile ricondurre le varietà di soluzioni tecnologiche di riferimento a tassonomie interpretative che ne consentano una comprensione sufficiente per un primo approccio progettuale.
I risultati dell’apprendimento saranno verificati in base alla comprensione effettiva dei contenuti citati - e delle loro reciproche interrelazioni -, con particolare riferimento alla capacità critica di inquadrare gli argomenti del corso, di comunicare efficacemente gli spunti di riflessione, di padroneggiare il vocabolario linguistico di riferimento, di elaborare un primo approccio qualitativo alla progettazione dell’ambiente costruito sostenibile.
Lo studente acquisisce, in particolare, abilità operativa nel padroneggiare una check-list interpretativa in grado di discretizzare la complessità dell’approccio alla Progettazione Tecnologico Ambientale in temi e sottotemi di riferimento. Tale strumento interpretativo è inteso come supporto alla riflessione metodologica, anche funzionale a porre a sistema e riconcettualizzare il know-how e le capacità interpretative pregresse a riguardo del progetto di architettura come esito dello sguardo multidisciplinare.
Sono considerati assimilati: la conoscenza base degli strumenti metodologici attraverso i quali lavora la cultura tecnologica in rapporto al progetto di architettura; la conoscenza base sulle caratteristiche dei principali materiali/semilavorati/prodotti edilizi e dei sistemi costruttivi attraverso i quali si concretizza la concezione del dettaglio tecnologico (anche nel quadro dell’approccio esigenziale al progetto); la comprensione critica e la padronanza lessicale nel comunicare efficacemente le riflessioni al riguardo; l’abilità nel tradurre le nozioni acquisite in propositività progettuale - sia in relazione al progetto di nuovi insediamenti che all’intervento sull’esistente - perseguendo una strategia coerente con la visione generale che informa il progetto, anche a partire dalle suggestioni derivanti dalle altre competenze disciplinari.
Le lezioni erogate ex cathedra riguardano:
- L’attualizzazione del rapporto tecnica/forma nel paesaggio costruito: la relazione con le caratteristiche ambientali come occasione di ricerca di qualità morfologica, distributiva, costruttiva, di linguaggio dell’architettura (4,5 ore);
- l’evoluzione del concetto di architettura ambientalmente sostenibile nel Novecento e nel nuovo millennio: crisi energetiche, quadri geopolitici, sperimentazioni, condivisione sociale (3 ore);
- architettura sostenibile e approccio transcalare al progetto, alla scala dell’edificio e del lotto: la lezione della storia e il dibattito contemporaneo (4,5 ore);
- i paradigmi e la check-list del costruito ambientalmente sostenibile (4,5 ore);
- i principi base per il progetto sostenibile: il rapporto con il microclima, con le risorse ambientali, con l’energia, attraverso le attenzioni morfologico-insediative, i dispositivi volumetrici e tecnico/spaziali per l’involucro edilizio, i sistemi costruttivi evoluti, le tecnologie ambientali per gli spazi aperti (40,5 ore);
- gli apparati normativi di incentivo alla qualità ambientale del costruito e di indirizzo/valutazione/certificazione (cenni: 1,5 ore);
- il concetto di innovazione tecnologica in architettura, con particolare riferimento ai rapporti di reciprocità con le accezioni di significato della sostenibilità del costruito (cenni: 1,5 ore).


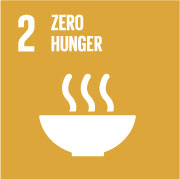





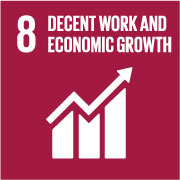


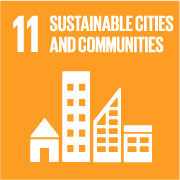
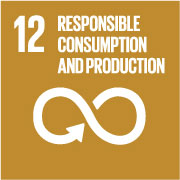



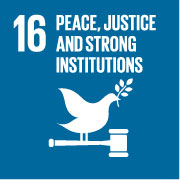

L’erogazione dei contenuti dell’insegnamento avviene, in prevalenza, attraverso lezioni monografiche ex cathedra (cfr.sopra la voce “Programma”) da parte del docente titolare del corso, anche individuando come lente critica di riferimento un tema-guida posto in relazione all’attualità dei fatti in corso nel dibattito internazionale.
Potranno, inoltre, essere previste altre modalità di approfondimento e comunicazione, tra le quali
- confronti con esperti, operatori del settore, aziende produttrici e altri stakeholders;
- confronti con progettisti.
Inoltre, potrebbe essere programmato - verificandone le condizioni di fattibilità organizzativa ed economica - un viaggio di studio (viaggio, comunque, opzionale), finalizzato ad approfondire i contenuti attraverso visite in loco: la presa di contatto diretta con il contesto culturale e fisico nel quale i segni del costruito oggetto di studio si inseriscono è individuata come occasione fondamentale per la maturazione di una reale consapevolezza da parte dello studente.
Tali visite impegneranno un monte ore da conteggiare, evidentemente, anche oltre il carico didattico del corso stesso.
Costituiscono base fondamentale per la preparazione dell’esame le dispense e i testi elaborati dalla docenza, in forma di presentazioni digitali corrispondenti ad ogni lezione.
I file ppt e pdf delle presentazioni del docente saranno scaricabili dal portale della didattica.
Costituiscono, dunque, parte integrante del programma del corso, le seguenti pubblicazioni:
- A. Mazzotta, Sostenibilità a scala insediativa: il ruolo delle tecniche, in: “Primo Congresso Internazionale di Retevitruvio per gli anni accademici 2010-2012, Polibapress” (ITA), Sessione “Il progetto di architettura fra didattica e ricerca”, Bari 2-6 maggio 2011, Vol. 1;
- A. Mazzotta, L’acqua materia e immagine per il paesaggio costruito. Indicazioni manualistiche tra sostenibilità e sensibilità, Alinea, Firenze 2007.
- A. Mazzotta, Spazi aperti next generation: la climatizzazione di microambienti non confinati, in: "Il Progetto sostenibile", Edicom, 2010, vol. 26;
Inoltre, si indica di seguito una selezione di testi utili per successivi apprendimenti: si tratta di un primo elenco sommario (la bibliografia di riferimento potrà essere completata a seconda degli specifici temi via via appronditi, anche su richiesta degli studenti stessi).
A) Sul rapporto tra costruzione del paesaggio, ambiente, tecnica, linguaggi dell’architettura sostenibile:
- Ian L. Mc Harg, Design with Nature, NHP, New York 1969;
- Martin Heidegger, Costruire, abitare, pensare, in “Lotus”, n° 9, Milano 1975;
- Dominique Gauzin-Müller, Architettura sostenibile, 29 esempi europei di edifici e insediamenti ad alta qualità ambientale, Edizioni Ambiente, Milano 2003;
B) Sull’inquadramento del tema ambientale in rapporto ai modelli di sviluppo:
- Donatella e Dennis Meadows, Jorgen Randers, I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio, Mondadori, Milano 2006;
C) Riviste di architettura, anche tematizzate sugli aspetti di dettaglio costruttivo e di sostenibilità ambientale in architettura:
“Detail”;
“Arketipo”;
“Il progetto sostenibile”;
“Materia”;
“Costruire in laterizio”.
Modalità di esame: Prova scritta (in aula);
Exam: Written test;
...
Insegnamento con esame individuale.
Modalità d’esame: solo scritto.
Durata dell’esame: max 120 minuti.
Tipologia: test con domande sia a risposta multipla che a risposta aperta.
Contenuto del test: è elaborato in base al criterio della necessità di verificare sia l’acquisizione della conoscenza, sia della comprensione, sia delle abilità (cfr, “Risultati di apprendimento attesi”).
Articolazione: 17 quesiti (in particolare 13 a risposta chiusa e 4 a risposta aperta).
Punteggio:
- ad ogni risposta esatta vengono attribuiti 2 punti;
- ad ogni risposta errata vengono sottratti 0,5 punti;
- le risposte lasciate in bianco sono equivalenti a 0 punti.
In relazione alle domande con risposta aperta, potrebbero essere attribuite frazioni di punto, in relazione alla completezza parziale delle risposte fornite.
L’esame è superato a partire dalla soglia di 9 risposte corrette alle relative domande, cui corrisponde la votazione di 18/30. Alla totalità di risposte corrette (17, equivalenti a 34 punti) corrisponde una votazione di 30 e lode.
Esercitazione (facoltativa):
è data la possibilità allo studente di preparare - durante il semestre di erogazione del corso - un “mini-saggio” critico inerenti argomenti riconducibili al tema del rapporto tra tecnologia, qualità ambientale del paesaggio costruito, linguaggio dell’architettura.
L’elaborato è inteso come comparazione critica tra concetti e/o casi studio, che consenta di evidenziare da parte dello studente stesso l’acqusitica capacità di leggere con un criterio intrepretativo articolato il tema oggetto di studio.
Punteggio specifico attribuito a questa esercitazione:
- elaborato eccellente = + 4 punti;
- elaborato non soddisfacente = - 4 punti.
La griglia di valutazione attraverso la quale si valuta la qualità dell’elaborato è articolata attraverso queste voci:
- pertinenza del caso studio scelto (ovvero: il caso architettonico/il concetto consente di svolgere un ragionamento attinente ai temi della qualità ambientale del costruito a scala di edificio e di lotto?);
- originalità dell’approccio critico (ovvero: l’articolazione dello scritto è impostato secondo uno schema che consenta di sviluppare un ragionamento di analisi critica e, in quanto tale, non banalizzata?);
- capacità di deduzione critica: (ovvero: le conclusioni cui si è pervenuti – sistematizzando e analizzando le fonti bibliografiche nel contesto nazionale e internazionale - derivano coerentemente dall’impostazione del ragionamento?);
- rapporto testo/figura (ovvero: l’apparato iconografico è funzionale a veicolare i contenuti enunciati nello scritto, nella loro complessità?);
- qualità delle fonti bibliografiche (ovvero: le fonti bibliografiche utilizzate coprono in modo esaustivo ed aggiornato l’argomento di dissertazione? Sono rappresentative della riflessione nazionale e internazionale?).
Per ognuna di queste voci è attributi un punteggio che può oscillare da -4 a + 4: il giudizio generale deriva dalla media matematica tra i giudizi ottenuti, perfezionata secondo i criteri normalmente in uso per l’arrotondamento.
Verranno attribuite anche frazioni di punto, in relazione alla completezza parziale delle risposte.
Il punteggio acquisito a seguito del buon esito della valutazione del mini saggio-critico andrà ad incrementare il punteggio raggiunto a mezzo del test scritto, compensando eventuali risposte mancate o errate.
Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
