Elenco notifiche

Caricamento in corso...
Atelier Città e Territorio F
01STEPM
A.A. 2019/20
Lingua dell'insegnamento
Italiano
Corsi di studio
Organizzazione dell'insegnamento
| Didattica | Ore |
|---|---|
| Lezioni | 42 |
| Esercitazioni in aula | 18 |
| Tutoraggio | 35 |
Docenti
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Loy Nadia
Atelier Città e Territorio F (Probabilità e statistica matematica) |
Ricercatore a tempo det. L.240/10 art.24-B | MATH-04/A | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Corrado Federica
Atelier Città e Territorio F (Urbanistica) |
Professore Associato | CEAR-12/A | 42 | 18 | 0 | 0 | 6 |
Didattica
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari |
|---|
2019/20
L’Atelier Città e Territorio guida gli studenti nella progressiva esplorazione del progetto architettonico, visto nelle sue relazioni con le dimensioni e i significati della città. L’Atelier, attraverso i contributi disciplinari coordinati della Composizione Architettonica e Urbana, dell’Urbanistica e della Matematica, supera la nozione di oggetti architettonici autonomi e sviluppa le relazioni del progetto con il contesto, facendo interagire le sfere teoriche, tecniche e pratiche con cui lavorare nello spazio costruito. L’Atelier si concentra su: letture e interpretazioni dello spazio, possibili impieghi dei dati quantitativi e loro rappresentazioni; dialettica fra visioni prescrittive basate sugli usi del suolo e codici morfologici.
The “City and Territory” Studio introduces students to additional explorations of architectural design in relationships with the city, its different dimensions and meanings. Via coordinated disciplinary contributions of ‘Architectural and Urban Design’, ‘Urban Planning’ and ‘Probability and Statistics’, the studio intends to overcome the notion of spatial design as made of independent architectural objects. The studio’s aim is to unfold the relationships between design and its related context, as well as to establish linkages between theoretical, technical and practical spheres in the built space. The studio revolves around: ways of reading and interpreting space; potential of handling and using quantitative data, and their conventional visualization; tensions between prescriptive visions based on land uses and morphological codes.
In continuità con il percorso avviato nel primo anno prosegue nell’Atelier Città e Territorio la predisposizione del toolbox personale dello studente con ragionamenti sui riferimenti progettuali, la competenza normativa tecnica di base, la capacità di elaborare schemi distributivi in varie dimensioni. Gli avanzamenti attesi riguardano in particolare la capacità di lavorare, individualmente e in gruppo, sviluppando:
- un approccio integrato al progetto e al programma: saper analizzare e interpretare criticamente insiemi urbani definiti rispetto a dimensioni più comprensive della città e dell’urbanizzazione contemporanei;
- competenze nella lettura morfologica degli insediamenti: saper riconoscere criticamente principi dispositivi e insediativi funzionali ad elaborare e argomentare idee di progetto;
- la capacità di utilizzare strumenti sintetici per la comprensione delle occasioni progettuali: capire gli indicatori statistico-quantitativi ed operare criticamente rispetto ad eventuali parametri assunti dai regolamenti esistenti (quali densità e standard urbanistici convenzionali) in funzione del progetto urbano;
- le competenze utili a riconoscere le relazioni con la forma del suolo e gli elementi costitutivi del paesaggio in una logica progettuale;
- l’attitudine alla sintesi dei ragionamenti svolti attraverso il progetto d’architettura urbana, inteso come momento di discontinuità rispetto all’esistente.
Following on the first year experience, the City and Territory Studio enriches the student's personal toolbox with additional reasoning on design references, the basic competence in regulatory techniques, and skills in defining spatial layouts at different dimensions and in different scales. The expected learning outcomes concern specifically the ability to work, individually and in teams, developing:
- an integrated approach to spatial design and programmes: how urban agglomerations may be critically analyzed and interpreted with reference to broader understanding of the contemporary city and urbanization processes;
- multifaceted competences in the morphological analysis of settlements: how to critically understand settlement’s functioning and spatial models, instrumental to elaboration and discussion of design ideas;
- skills in handling quantitative tools to understand design opportunities: how to use statistical-quantitative indicators and operate critically with any parameters incorporated in the existing regulations (such as density and conventional urban standards), instrumental to urban design;
- skills in recognizing, by means of design, the relationships between topography and the constituent elements of landscape;
- an attitude to synthesize critical reasoning through urban design, intended as a moment of reconfiguration of what exists.
L’Atelier si costruisce a partire dalle competenze acquisite nel corso del primo anno “Istruzioni”. In particolare, l’Atelier presuppone che gli studenti abbiano acquisito le conoscenze critiche e progettuali di base dell’Atelier Fondamenti di Progettazione, degli strumenti di lettura ed elaborazione della città contemporanea trasmessi dal corso di Urbanistica del primo anno, unitamente alla conoscenza degli elementi di tecnica urbanistica utili a muoversi con familiarità nei quadri normativi attivi nelle aree progetto. L’Atelier richiede inoltre che gli studenti possiedano i fondamenti di algebra lineare, calcolo differenziale e calcolo integrale acquisiti nel corso di Istituzioni di Matematiche
The studio builds upon the skills that students gained in the first year "Instructions" programme. In particular, the studio assumes that students have acquired: the basic critical understanding and design knowledge of the first year Architecture Design Studio; the analytical tools to understand and elaborate on the contemporary city developed in the first year Urban Planning course, together with the knowledge of elements of urban planning technique. The studio also requires that students possess the fundamentals of linear algebra, differential and integral calculus acquired during the Calculus course.
Anno per anno, gli Atelier si coordinano per concordare un tema generale comune che riguardi quadri di trasformazione della città contemporanea, capaci di catalizzare ulteriori integrazioni con gli altri corsi del semestre. L’obiettivo è garantire agli studenti una coerenza nell’offerta formativa basata sulla confrontabilità dei risultati didattici e degli elaborati, oltre a migliorare la visibilità esterna per iniziative di comunicazione e pubblicistiche. Ciascun atelier avrà la possibilità di declinare i temi concordati in relazione alle idee e alle attitudini dei docenti referenti, prevedendo direzioni e modalità di approfondimento diverse. Il sito di esercitazione progettuale è una parte di città o di territorio – quale il quartiere residenziale, il borgo compatto, il settore urbano, o simili – che consenta di condividere informazioni di riferimento prima dell’inizio dei corsi, di effettuare sopralluoghi e accedere alle fonti o agli archivi di dati urbani durante il semestre. Attraverso l’analisi del sito e l’esercizio progettuale, gli studenti si misureranno con una dimensione micro-urbana di lavoro, in cui affrontare il progetto urbano ex novo o alternativo alle condizioni attuali. I passaggi continui dalla dimensione del contesto di lavoro alla comprensione dei fenomeni urbani contemporanei consentono di maturare specifiche competenze relativamente ai temi dell’urbanità e del cambio di scala nelle trasformazioni dell’ambiente antropogeografico. Sarà inoltre proposta nell’Atelier la rivisitazione in chiave attuale delle letture quantitative e orientate alla valutazione del territorio o del sistema ambientale.
Il tema di lavoro. L’Atelier propone a livello microurbano la ridefinizione di un “vuoto” urbano e del suo intorno nella zona centrale di Torino. Il corso pone quindi particolare attenzione alla ridefinizione delle funzioni e della forma urbana, che andranno ridiscusse rispetto alle attuali ipotesi di PRG, sviluppando in premessa e in parallelo un’indagine interdisciplinare estesa ad un’area più vasta con la quale il tema rimane in costante dialogo critico. Il punctum è rappresentato da una situazione irrisolta, residuale delle demolizioni belliche nel centro storico, in un contesto di cerniera tra Quadrilatero ed espansioni ottocentesche che ha il suo epicentro nel piazzale Amelia Piccinini: tema reso interessante dalla presenza di importanti scenografie architettoniche, del verde dei viali e da un pervasivo e discontinuo decoro urbano consolidatosi tra Sette e Novecento. Di questo fulcro e dell’intorno verranno illustrate le premesse storico- urbanistiche e storico- architettoniche.
Quadro e contesto urbano di riferimento – che motiverà le scelte da operare a livello specifico sul tema – è una zona assai più estesa e contradditoria, che lambisce le zone di Valdocco, del Quadrilatero e del Passante ferroviario. Sarà indispensabile premessa la formulazione di un concept di progetto che – come in un racconto circolare - illustri le valenze dell'intorno rispetto all’ intervento e dell’intervento rispetto all'intorno concentrandosi poi sulla scala microurbana e architettonica. L’esperienza didattica si basa in questa fase su un ragionamento induttivo – che presuppone la conoscenza ma non necessariamente la consequenzialità rispetto allo strumento urbanistico - per intervenire piuttosto su nodi significativi del tessuto urbano verificandone le reazioni possibili.
L’analisi preliminare del concept, svolta in comune con le altre materie, è da intendersi come primo punto di verifica delle ipotesi acquisite, e come indispensabile aggiornamento collettivo tra studenti e docenti per lo stabilirsi di un linguaggio condiviso all’interno dell’atelier.
Year by year, the Ateliers are coordinated to agree on a common general theme concerning transformations of the contemporary city, capable of catalyzing further integrations with the other courses of the semester. The objective is to guarantee students a coherence in the educational offer based on the comparability of teaching results and papers, as well as improving external visibility for communication and publicity initiatives. Each atelier will have the opportunity to discuss the agreed themes in relation to the ideas and attitudes of the referring teachers, providing different directions and methods of study. The design training site is a part of the city or territory - such as the residential district, the compact village, the urban sector, or similar - which allows for sharing of reference information before the start of the courses, carrying out inspections and accessing the sources or archives of urban data during the semester. Through the analysis of the site and the design exercise, the students will measure themselves with a micro-urban dimension of work, in which to face the urban project from scratch or as an alternative to the current conditions. The continuous passages from the dimension of the work context to the understanding of contemporary urban phenomena allow to develop specific competences in relation to the themes of urbanity and change of scale in the transformations of the anthropogeographic environment. The Atelier will also present a review of the quantitative and environmental assessment readings in a current key.The work topic. At the micro-urban level, the Atelier proposes the redefinition of an urban "void" and its surroundings in the central area of Turin. The course therefore pays particular attention to the redefinition of functions and urban form, which will be re-discussed with respect to the current hypotheses of PRG, developing in the introduction and in parallel an interdisciplinary survey extended to a wider area with which the theme remains in constant critical dialogue. The punctum is represented by an unresolved situation, residual of the war demolitions in the historical center, in a context of hinge between the Quadrilateral and nineteenth-century expansions that has its epicenter in the square Amelia Piccinini: theme made interesting by the presence of important architectural sets, the green of avenues and a pervasive and discontinuous urban decoration consolidated between the Seven and Twentieth Century. The historical-urban planning and historical-architectural premises of this fulcrum and of the surroundings will be illustrated. The framework and urban context of reference - which will motivate the choices to be made at a specific level on the subject - is a much more extensive and contradictory area, which borders the areas of Valdocco, the Quadrilateral and the Passante railway. The formulation of a project concept will be indispensable, which - as in a circular story - illustrates the values of the surroundings with respect to the intervention and the intervention with respect to the surroundings, then focusing on the micro-urban and architectural scale. In this phase, the didactic experience is based on an inductive reasoning - which presupposes knowledge but not necessarily the consequentiality with respect to the urbanistic instrument - to intervene rather on significant nodes of the urban fabric, verifying the possible reactions. The preliminary analysis of the concept, carried out in common with the other subjects, is to be understood as the first point of verification of the hypotheses acquired, and as an indispensable collective update between students and teachers to establish a shared language within the atelier.


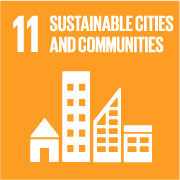
Altre informazioni relative all’insegnamento, utili in sede di coordinamento e valutazione, non previste nei campi precedenti. Non è necessario compilare ora questa parte.
Altre informazioni relative all’insegnamento, utili in sede di coordinamento e valutazione, non previste nei campi precedenti. Non è necessario compilare ora questa parte.
Modulo di Composizione architettonica e urbana .
Prima fase (1: 2000-1:500). In parallelo al sopralluogo guidato e alle lezioni introduttive il corso prevede una preliminare fase di masterplan da sviluppare su tutta l’area, con fulcri su nodi significativi da individuare con la docenza e la prima formulazione di un concept di progetto preferibilmente orientato sul focus in esame. In questa fase le correzioni avverranno per gruppi omologhi riuniti su temi affini, in modo da individuare connessioni e raffronti su aspetti comuni. In questa fase verrà inoltre richiesto di analizzare criticamente riferimenti di progetto, comparabili ai temi assegnati.
Esito di questa prima fase una presentazione collettiva nella quale i gruppi costruiranno una narrazione del concept, individuandone le principali scelte programmatiche. La discussione pubblica (che rappresenta obbligatoriamente uno step (non necessariamente valutativo, ma indispensabile alla prosecuzione dell’esperienza didattica) avverrà alla presenza di tutti i docenti dell’Atelier, in modo da orientare la scelta di approfondimento alla scala architettonica su obiettivi comuni.
Seconda Fase (1. 200-1: 100). La seconda fase esaminerà di preferenza la risoluzione del focus proposto (vuoto urbano di piazzale Amelia Piccinini e adiacenze), senza escludere in alternativa l’approfondimento di altri nodi interessanti emersi durante l’indagine di masterplan: il tema – anche nel suo orientamento funzionale - andrà comunque definito con la docenza in occasione della discussione pubblica del concept progettuale.
A partire dalla definizione del masterplan, i gruppi saranno chiamati a sviluppare il lavoro attraverso un approfondimento architettonico. La specificazione di determinate scelte progettuali sarà, in questa fase, occasione per ridefinire e assestare lo schema iniziale e ricostruire una narrazione coerente del progetto. Lo studente dovrà acquisire una prima visione dell’esperienza progettuale, nella sua complessità, prendendo coscienza della necessità di una continua revisione critica delle ipotesi assunte rispetto alle possibilità di verifiche interdisciplinari e specifiche - con una capacità di "chiudere" il tema su obiettivi definibili e concordati in itinere e di valutarne criticamente, a conclusione dell'atelier, i risultati. Lo studente dovrà quindi, per successive approssimazioni, individuare le linee di sviluppo di una proposta giustificabile criticamente nel rapporto con le premesse interdisciplinari e nella sua complessiva articolazione distributive. In questo senso, l’insegnamento della Composizione Architettonica e Urbana dissente da aprioristiche metodologie, mirando piuttosto alla formazione graduale, tra lezioni ed esercitazioni, di un’opinione comune sul tema tra docenti e studente, partendo da un nodo qualsiasi purchè suggestivo e forte per iniziare ad affrontare il percorso: in questo scenario il docente non è demiurgo ma testimone attento alla linea tracciata dall’allievo, per aiutarlo a raggiungere un esito progettuale coerente.
Modulo di Urbanistica
Rispetto al tema di lavoro, il contributo di Urbanistica viene organizzato in 3 step principali, a ciascuna della quali coincide una specifica task: 1. Analisi territoriale : lettura interpretativa del territorio al fine di comprendere e descrivere le dinamiche urbane in atto; 2. studio di casi nel panorama europeo utili a comprendere la complessità del fenomeno urbano odierno indagato nel cao studio individuato; 3. definizione di un concept di progetto; 4. Elaborazione “masterplan”, inteso come approfondimento progettuale a scala locale all’interno di una vision urbana più complessiva.
Il lavoro viene svolto in gruppi. Sono previste revisioni congiunte, al fine di facilitare il coordinamento tra le diverse discipline e verificare l’avanzamento del lavoro degli studenti.
Modulo di Modelli matematici e statistici per le scienze del territorio
Al secondo anno sono previsti due crediti di Matematica all’interno dell’Atelier di Urbanistica.
Il contributo della matematica nell'Atelier del secondo anno ha come obiettivo di fornire strumenti per la lettura quantitativa del territorio. Tali strumenti consisteranno in opportuni indicatori costruiti sull'ampia base di dati territoriali che il Laboratorio di Geomatica (in parallelo nello stesso periodo didattico) potrà fornire. Tali indicatori risulteranno essere quindi strumenti sintetici per la lettura e la valutazione, nei vari ambiti e declinazioni, del territorio o del sistema ambientale sotto osservazione. Gli indicatori potranno poi essere inseriti anche in semplici modelli matematici per ulteriori valutazioni sulla resilienza del territorio stesso. Nell'elaborazione dei dati disaggregati del territorio, ottenuti dalle mappe geomatiche, potranno essere usati semplici strumenti di statistica descrittiva. Tale proposta didattica è quindi tipica della modellistica matematica e pertanto è naturalmente collocata nel settore disciplinare MAT/07.
Architectural and urban composition module.
First phase (1: 2000-1: 500). In parallel with the guided inspection and the introductory lessons, the course includes a preliminary masterplan phase to be developed throughout the area, with hubs on significant nodes to be identified with the teaching and the first formulation of a project concept preferably focused on the focus in question . In this phase the corrections will be made for homologous groups gathered on similar themes, in order to identify connections and comparisons on common aspects. In this phase it will also be required to critically analyze project references, comparable to the assigned themes.
The outcome of this first phase is a collective presentation in which the groups will build a narrative of the concept, identifying the main programmatic choices. The public discussion (which necessarily represents a step (not necessarily evaluative, but essential to the continuation of the teaching experience) will take place in the presence of all the Atelier teachers, in order to direct the choice of deepening to the architectural scale on common objectives.
Second Phase (1. 200-1: 100). The second phase will preferably examine the resolution of the proposed focus (urban void of piazzale Amelia Piccinini and adjacencies), without excluding as an alternative the in-depth study of other interesting nodes emerged during the masterplan survey: the theme - also in its functional orientation - it will in any case be defined with the lecturer on the occasion of the public discussion of the project concept.
Starting from the definition of the masterplan, the groups will be asked to develop the work through an architectural study. The specification of certain design choices will be, at this stage, an opportunity to redefine and adjust the initial scheme and reconstruct a coherent narrative of the project. The student will have to acquire a first vision of the design experience, in its complexity, becoming aware of the need for a continuous critical revision of the hypotheses assumed with respect to the possibilities of interdisciplinary and specific verifications - with an ability to "close" the theme on definable objectives and agreed in itinere and to critically evaluate, at the end of the workshop, the results. The student will then, by successive approximations, identify the lines of development of a proposal that can be critically justified in the relationship with the interdisciplinary premises and in its overall distribution distribution. In this sense, the teaching of Architectural and Urban Composition disagrees with a priori methodologies, aiming rather at the gradual training, between lessons and exercises, of a common opinion on the subject between teachers and student, starting from any node, purely suggestive and strong for begin to face the path: in this scenario the teacher is not a demiurge but a witness attentive to the line drawn by the student, to help him reach a coherent project outcome.
Urban Planning Module
In relation to the theme of work, the teaching about spatial planning is articulted in three steps: 1. territorial analysis dedicated to the interpretation and description of territorial dynamics; 2. Analysis of case studies in the European urban context able to deep the urban phenomenon individuated in the Atelier; 3. Elaboration of the territorial concept; 4. Elaboration of the masterplan in which is explorated the local territorial project referred to a more complex urban vision
The students work in goups. Correction, seminars, public revisions are previewed in collaboration with the other disciplines of the Atelier.
Mathematical and statistical models for local sciences module
In the second year there are two credits in Mathematics within the Atelier of Urban Planning. The goal of mathematics in the Atelier of the second year is to provide tools for quantitative reading of the territory. These tools will consist of appropriate indicators built on the broad spatial data base that the Geomatics Laboratory (in parallel during the same teaching period) will be able to provide. These indicators will therefore be synthetic tools for reading and evaluating the territory or environmental system under observation in the various areas and forms. The indicators can then also be inserted in simple mathematical models for further evaluations on the resilience of the territory itself. In the elaboration of the disaggregated data of the territory, obtained from the geomatic maps, simple tools of descriptive statistics can be used. This didactic proposal is therefore typical of mathematical modeling and is therefore naturally placed in the disciplinary sector MAT / 07.
Sintesi degli argomenti trattati, copia delle slides usate durante le lezioni e documenti utili all'organizzazione delle attività dei gruppi saranno disponibili sul portale della didattica. Indicazioni bibliografiche specifiche sui riferimenti tecnico normativi e sull’ambito territoriale oggetto dell’esercitazione verranno specificate nelle lezioni e richiamate sul portale, in relazione alle specifiche esigenze dei temi affrontati nell'attività dell'Atelier. E’ auspicabile la consultazione aggiornata delle principali riviste di architettura e la capacità di una corretta schedatura critica dei riferimenti riscontrabili sui siti web.
A livello generale e specifico, si richiama intanto la seguente bibliografia di base:
Architettura Tecnica del Politecnico di Torino, Forma Urbana e Architettura nella Torino barocca. Torino, TTE, 1968
V. COMOLI MANDRACCI, Torino. Laterza, Bari 1983
E. DELLAPIANA, Giuseppe Talucchi architetto. Celid, Torino 1999
A. MAGNAGHI, M. MONGE, L.RE, Guida all’architettura moderna di Torino. Designers Riuniti Editori, Torino, 1982
R.GABETTI, Imparare l’architettura. Scritti scelti sul sapere architettonico. Torino, Allemandi, 1997.
I tesori degli archivi. L’archivio di Stato di Torino. Nardini editore
E. PICCOLI, I progetti di Garove per il terzo ingrandimento di Torino, in “Michelangelo Garove 1648 1713. Un architetto per Vittorio Amedeo II”, Venaria Reale (Torino), 11-12 dicembre 2009. pp. 145-15
Politecnico di Torino, DISET. Torino nell’Ottocento e nel Novecento. Torino, Celid
P. GABELLINI, Tecniche urbanistiche. Roma, Carocci, 2001
G. PASQUI. La città, i saperi, le pratiche. Roma, Donzelli, 2018
G. DEMATTEIS, Per progettare il territorio. Archivio di studi urbani e regionali, 1991.
Summary of the topics covered, copies of the slides used during the lessons and documents useful for organizing the activities of the groups will be available on the teaching portal. Specific bibliographical references on technical-normative references and on the territorial scope of the exercise will be specified in the lessons and recalled on the portal, in relation to the specific needs of the topics addressed in the Atelier activity. The up-to-date consultation of the main architecture magazines and the ability of a correct critical indexing of the references found on the websites is desirable.
At the general and specific level, the following basic bibliography is recalled:
Architettura Tecnica del Politecnico di Torino, Forma Urbana e Architettura nella Torino barocca. Torino, TTE, 1968
V. COMOLI MANDRACCI, Torino. Laterza, Bari 1983
E. DELLAPIANA, Giuseppe Talucchi architetto. Celid, Torino 1999
A. MAGNAGHI, M. MONGE, L.RE, Guida all’architettura moderna di Torino. Designers Riuniti Editori, Torino, 1982
R.GABETTI, Imparare l’architettura. Scritti scelti sul sapere architettonico. Torino, Allemandi, 1997.
I tesori degli archivi. L’archivio di Stato di Torino. Nardini editore
E. PICCOLI, I progetti di Garove per il terzo ingrandimento di Torino, in “Michelangelo Garove 1648 1713. Un architetto per Vittorio Amedeo II”, Venaria Reale (Torino), 11-12 dicembre 2009. pp. 145-15
Politecnico di Torino, DISET. Torino nell’Ottocento e nel Novecento. Torino, Celid, 1995
P. GABELLINI, Tecniche urbanistiche. Roma, Carocci, 2001
G. PASQUI. La città, i saperi, le pratiche. Roma, Donzelli, 2018
G. DEMATTEIS, Per progettare il territorio. Archivio di studi urbani e regionali, 1991.
Modalità di esame: Elaborato grafico prodotto in gruppo; Elaborato scritto individuale;
Exam: Group graphic design project; Individual essay;
...
L'esame consisterà nella presentazione da parte dei gruppi, dei risultati della ricerca progettuale attraverso l'esposizione degli elaborati sviluppati nel corso dell'atelier. L’esame verrà svolto in forma di atelier, cioè alla presenza dei docenti delle tre discipline, e consisterà nell’illustrazione del progetto sotto agli aspetti interdisciplinari e specifici: la valutazione terrà conto della presentazione e discussione degli elaborati finali e del lavoro complessivamente svolto dal gruppo, partendo da un apporto critico di rilettura individuale la cui discussione partirà da una relazione scritta. Per poter sostenere l’esame a ogni studente è richiesta, oltre alla partecipazione (insieme al proprio gruppo) alle revisioni collettive, la presenza allo step intermedio di presentazione.
La valutazione finale terrà conto della presentazione e discussione degli elaborati finali (40%), del lavoro complessivamente svolto dal gruppo nel corso del semestre (40%), ma anche della partecipazione individuale a tale lavoro e ai momenti di presentazione, (20%).
Prima Fase. Materiali richiesti: 1 Tavola; modello di studio; album in formato A4 verticale contenente materiali della ricerca e del progetto; presentazione onnicomprensiva in PDF/ JPG
Seconda Fase (esame). La valutazione dei risultati della Seconda Fase verrà condotta a partire dai seguenti criteri: Capacità di sviluppo del progetto architettonico in coerenza alla definizione del concept nella prima fase; capacità di utilizzo dell'approfondimento progettuale come strumento ulteriore di ridefinizione e verifica delle ipotesi precedentemente poste; capacità di individuazione complessiva degli aspetti distributivi e funzionali del progetto – realtivamente alla scala richiesta; capacità di restituzione grafica e attraverso i modelli di studio delle proposte progettuali. Materiali richiesti: Relazione individuale; 3 Tavole; modello di studio; album aggiornato in formato A4 verticale contenente materiali della ricerca; presentazione onnicomprensiva in PDF /JPG.
L’insufficienza anche in uno solo dei contributi non consente di superare l’Atelier.
Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
Exam: Group graphic design project; Individual essay;
The exam will consist in the presentation by the groups of the results of the project research through the exhibition of the works developed during the workshop. The exam will be carried out in the form of an atelier, ie in the presence of the teachers of the three disciplines, and will consist of the illustration of the project under the interdisciplinary and specific aspects: the evaluation will take into account the presentation and discussion of the final papers and the overall work done by the group, starting from a critical contribution of individual re-reading whose discussion will start from a written report. In order to take the exam, each student is required, in addition to participating (together with their group) in collective reviews, to attend the intermediate step of presentation.
The final evaluation will take into account the presentation and discussion of the final papers (40%), the overall work carried out by the group during the semester (40%), but also the individual participation in this work and the presentation moments (20%) .
First Phase. Required materials: 1 Table; model of study; A4 format vertical album containing research and project materials; comprehensive presentation in PDF / JPG
Second Phase (exam). The evaluation of the results of the Second Phase will be carried out starting from the following criteria: Ability to develop the architectural project in line with the definition of the concept in the first phase; ability to use the in-depth analysis of the project as an additional tool for redefining and verifying the hypotheses previously set; ability to identify the distribution and functional aspects of the project in general - in accordance with the required scale; capacity for graphic restitution and through the study models of project proposals. Materials required: Individual report; 3 tables; model of study; updated album in A4 format containing research materials; comprehensive presentation in PDF / JPG.
The insufficiency of even one of the contributions does not allow the Atelier to be overcome.
In addition to the message sent by the online system, students with disabilities or Specific Learning Disorders (SLD) are invited to directly inform the professor in charge of the course about the special arrangements for the exam that have been agreed with the Special Needs Unit. The professor has to be informed at least one week before the beginning of the examination session in order to provide students with the most suitable arrangements for each specific type of exam.