Elenco notifiche

Caricamento in corso...
Atelier Fondamenti di Progettazione A
01SSGPM
A.A. 2024/25
Lingua dell'insegnamento
Italiano
Corsi di studio
Corso di Laurea in Architettura - Torino
Organizzazione dell'insegnamento
| Didattica | Ore |
|---|---|
| Lezioni | 20 |
| Esercitazioni in aula | 40 |
| Tutoraggio | 35 |
Docenti
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolfo Davide | Professore Associato | CEAR-09/A | 20 | 40 | 0 | 0 | 2 |
Collaboratori
Espandi
Riduci
Riduci
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muci Fabrizia | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 0 | 0 | 35 |
Didattica
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari | ICAR/14 | 6 | B - Caratterizzanti | Progettazione architettonica e urbana |
|---|
2024/25
L'atelier è il primo contatto dello studente con la progettazione dell’architettura. L’insegnamento si propone quindi di fornire allo studente le conoscenze e le abilità necessarie al saper riconoscere e progettare gli spazi a scala architettonica, anche in relazione ad un contesto e ad un programma volutamente semplificati. L’articolazione del
percorso didattico in più esercizi tematici consecutivi permette allo studente di misurarsi con i fondamenti della progettazione avvicinandosi progressivamente alla complessità del progetto architettonico nella sua interezza. Il primo atelier introduce così la sequenza dei laboratori progettuali interdisciplinari in cui si struttura la laurea Triennale.
The design studio is the student's first contact with architectural design. The teaching is therefore proposed to provide the student with the knowledge and skills necessary to be able to recognize and design spaces at ARCHITECTURAL scale, also in relation to a deliberately simplified context and program. The articulation of the educational path in several consecutive thematic exercises allows the student to measure himself with the fundamentals of design, progressively approaching the complexity of the architectural project in its entirety. The first Design Studio thus introduces the sequence of interdisciplinary design laboratories in which the Bachelor programme is structured.
Le conoscenze e abilità la cui effettiva acquisizione sarà verificata in sede di esame si strutturano intorno a quattro assi tematici:
1 Spazio:
Conoscenze: Tipi e caratteri dello spazio tri-dimensionale
Abilità: saper leggere, scomporre e comporre lo spazio tri-dimensionale in unità semplici e in configurazioni complesse; saper riconoscere i diversi tipi di spazi.
2 Caratteri distributivi:
Conoscenze: caratteri distributivi residenziali elementari
Abilità: saper analizzare l’organizzazione della circolazione in spazi semplici e quindi comporre schemi distributivi elementari.
3 Riferimenti progettuali:
Conoscenze: riferimenti per il progetto
Abilità: saper riconoscere, scegliere e ridisegnare consapevolmente i riferimenti progettuali.
4 Principi di morfologia costruttiva:
- Relativamente alla struttura:
Conoscenze: rapporto pelle/struttura
Abilità: riconoscere le diverse possibili configurazioni strutturali di una architettura semplice, proporre e sviluppare la forma strutturale in relazione alle caratteristiche dello spazio ed alla organizzazione della distribuzione.
- Relativamente alle tecniche costruttive :
Conoscenze: Relazione tra principi costruttivi fondamentale e immagine architettonica.
Abilità: riconoscere e impiegare i principi costruttivi fondamentali e il significato architettonico delle tecnologie proprie di una architettura semplice, e svilupparne l’applicazione in coerenza con gli altri aspetti del progetto.
The knowledge and skills whose actual acquisition will be verified during the examination are structured around four thematic axes:
1 Space
Knowledge: types and characters of the three-dimensional space
Skills: knowing how to read, break down and compose the three-dimensional space into simple units and complex configurations; know how to recognize the different types of spaces
2 Distribution characters
Knowledge: elementary residential distributive characters
Skills: to know how to analyse the organization of circulation in simple spaces and therefore to compose elementary distribution schemes
3 Design references
Knowledge: references for the project
Skills: knowing how to recognize, choose and consciously redesign design references
4 Principles of constructive morphology
Regarding the structure:
Knowledge: skin/structure relationship
Skills: recognizing the different possible structural configurations of a simple architecture, proposing and developing the structural form in relation to the characteristics of the space and to the organization of the distribution.
Regarding construction techniques:
Knowledge: relationship between fundamental constructive principles and architectural image Skills: recognizing and using the fundamental building principles and the architectural meaning of the specific technologies of a simple architecture, and to develop its application in coherence with the other aspects of the project.
Gestire agevolmente i fondamenti del disegno geometrico in termini di proiezioni ortogonali e di geometria proiettiva, discernere e rappresentare scale e dimensioni dello spazio architettonico mediante strumenti manuali. Utilizzare con agilità lo schizzo come strumento di rappresentazione e concezione dello spazio. Sapere realizzare semplici modelli tri-dimensionali reali di lavoro con materiali a basso costo e facilmente manipolabili (carta, balsa, polistirene, cartoncino, etc.).
E’ richiesto agli studenti di tenere, fin dall’inizio del primo semestre, un quaderno di schizzi e appunti grafici che documenti il proprio percorso di introduzione all’architettura, sia attraverso elaborazioni legate ai contenuti dei corsi del primo semestre, sia attraverso autonome ricerche. Il quaderno accompagnerà lo studente nel corso dell’atelier, documentando in forma grafica il percorso individuale di introduzione al progetto. Il quaderno è oggetto di valutazione in sede di esame finale.
Easily managing the fundamentals of geometric design in terms of orthogonal projections and projective geometry, Discerning and representing scales and dimensions of architectural space through manual tools. Skilfully using the sketch as a tool for representation and conception of space. Knowing how to make simple physical three-dimensional models with low cost and easily manipulated materials (paper, balsa, polystyrene, cardboard etc.) Students are asked to keep a sketch book and graphic notes from the beginning of the first semester to document his/her introduction to architecture, both through elaborations linked to the contents of the courses of the first semester, both through independent research. The notebook will accompany the student during the atelier, documenting in graphic form the individual path of introduction to the project. The notebook is subject to evaluation during the final exam.
Il laboratorio si sviluppa attraverso una sequenza di esercizi che affrontano, singolarmente o trasversalmente, i quattro assi tematici proposti (spazio, distribuzione, struttura, tecniche), riferendoli all’interpretazione di un programma architettonico semplice, legato all’abitare nelle sue diverse possibili declinazioni. Lo svolgimento delle esercitazioni sarà sia individuale che in gruppo. Le esercitazioni saranno svolte sia attraverso il disegno a mano sia attraverso la realizzazione di plastici di studio e modelli tridimensionali. L’avvio delle esercitazioni avverrà in aula, sotto la direzione dei docenti, sarà seguito da un successivo sviluppo autonomo da parte dello studente fuori dall’orario del laboratorio e quindi concluso da una verifica e discussione col docente degli elaborati, con cadenza settimanale. E’ perciò fortemente consigliata una frequenza continuativa del laboratorio.
I docenti offriranno e discuteranno con gli studenti esempi di architetture significative, nel loro insieme o per specifici aspetti; è richiesta agli allievi una autonoma e costante frequentazione di riviste on-line e cartacee di architettura, con la ricerca di propri riferimenti per i diversi temi proposti. E’ altresì consigliata la partecipazione alle attività culturali extra-curriculari organizzate dal Collegio di Architettura, e ad attività culturali esterne che potranno essere segnalate dai docenti. Ognuna delle esercitazioni si sviluppa indicativamente sull’arco di due/tre settimane. Le ultime due settimane sono dedicate alla rielaborazione di quanto fatto in una presentazione finale (elaborati grafici e modello fisico). Il coordinamento e lo scambio con il Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura potrà essere attivato sia al primo che al secondo semestre attraverso lezioni congiunte e verifiche periodiche sull’andamento degli insegnamenti. Eventuali temi esercitativi comuni in collaborazione con l'insegnamento di Cultura e fondamenti della tecnologia dell’architettura e/o con l'insegnamento di Morfologia e concezione delle strutture saranno comunicate all’inizio del II periodo didattico insieme alle relative modalità organizzative e tempi, che saranno concordate a livello di singola filiera.
The laboratory is developed through a sequence of exercises that address, individually or transversally, the four proposed thematic axes (space, distribution, structure, techniques), referring to the interpretation of a simple architectural program, focused on to dwelling in its possible variations. The exercises will be conducted both individually and in groups. The exercises will be carried out both through freehand and computer drawing and through the realization of study models and three-dimensional models. The start of the exercises will take place in the classroom, under the direction of the teachers, and it will be followed by a subsequent autonomous development by the student outside the studio hours, and then concluded by a check and discussion with the teacher, on a weekly basis. Therefore consistent attendance of the studio is strongly recommended. The teachers will present and discuss with the students examples of significant architectures, as a whole or for specific aspects; students are required to have an independent and constant attendance of on-line and paper architecture magazines, searching for references for the different themes proposed. It is also recommended to participate in extra-curricular cultural activities organized by the College of Architecture, and to external cultural activities that can be reported by the teachers. Each of the exercises takes approximately two weeks. The last two weeks are dedicated to the elaboration of what has been done in a final presentation (graphic works and physical model). Coordination and exchange with the architecture design and survey laboratory can be activated both at the first and in the second semester, through joint lectures and periodic checks on the progress of the courses. Possible common exercises in collaboration with the Culture and foundations of architectural technology course and/or with the Morphology and conception of structures course will be communicated at the beginning of the 2nd teaching period, together with the related organizational methods and times.

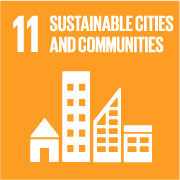

The student receives continuous feedback from the teacher on their progress thanks to the personal and the group reviews.
A joint collective review of the 6+1 laboratories is planned, indicatively in the middle of the second semester, and a final presentation of the papers, with joint critical discussion also in the presence of invited external experts.
The student receives continuous feedback from the teacher on their progress thanks to the personal and the group reviews.
A joint collective review of the 6+1 laboratories is planned, indicatively in the middle of the second semester, and a final presentation of the papers, with joint critical discussion also in the presence of invited external experts.
L'atelier affronta il tema dell'abitare nella città attraverso il progetto di una piccola casa d'abitazione. Questo oggetto architettonico seppur di dimensioni ridotte si articolerà in una relazione tra la dimensione domestica delle singole unità e il sistema di spazi pubblici e collettivi connessi ad esso. Una sequenza di esercizi sviluppati nel corso dell'atelier permetterà di affrontare il progetto a partire differenti temi di lavoro e di studiarlo e descriverlo attraverso molteplici tecniche di rappresentazione.
Gli esercizi proposti affrontano separatamente diversi aspetti dell'architettura costituendosi come base per la definizione del progetto. Nello sviluppo del lavoro si richiederà una costante riformulazione delle scelte progettuali intraprese tenendo conto dei temi trattati nella progressione delle esercitazioni.
Nel corso dell'atelier, il docente fornirà esempi e riferimenti che saranno discussi con gli studenti, ai quali saranno comunque richieste ricerche individuali finalizzate al proprio specifico percorso di apprendimento attraverso il progetto.
In ognuna delle esercitazioni, come anche nella rielaborazione finale, è sempre consentito allo studente singolo e al gruppo di ritornare sulle scelte precedenti in base a nuove ipotesi emerse nell’esplorazione progettuale.
The atelier deals with the theme of living in the city through the design of a small house. This small architectural object will be articulated in a relationship between the domestic and protected dimension of each unit and the system of public and collective spaces connected to it. A sequence of exercises developed during the course of the workshop will allow the project to be approached starting from different work themes and to study and describe it through various techniques of representation.
The proposed exercises deal separately with different aspects of architecture and form the framework for the definition of the project. In the development of the work, a constant reformulation of the design choices undertaken will be required, taking into account the topics dealt with in the progression of the exercises.
During the atelier, the teacher will provide examples and references that will be discussed with the students, who will still be required to carry out individual researchs aimed at their specific learning path through the project.
THE MINIMUM UNIT
In the first exercise, students are asked to develop individually, in plan and section, the design of a small apartment based on design references provided by the teacher. (2 weeks)
In all exercises and project phases teachers will provide layouts, templates and graphic styles which are common to all students.
UNDERSTANDING OF THE PROJECT AREA.
Students will be asked to redesign the assigned urban context starting from a mapping of its system of full and empty spaces and then from the real production of a first volumetric model. (physical in scale 1,200 or 3D) of the project area. (1 week)
THE TYPE FLOOR PLAN
Subsequently, students will be asked to draw up the plan of the type floor plan, identifying an appropriate housing and distribution system for the quantities assigned and the project context identified. From this first phase, the organizational module of the architectural layout will be requested, useful for the control and relationship between the different project tools (plan, section, elevation) and for the identification of its structural principles to be shared with the Morphology teacher. Simultaneously with the plan will be required the realization of a study model (physical scale 1,200 or 3D) as a first volumetric / quantitative verification. (2 weeks)
THE RELATIONSHIP BETWEEN BUILT AND EMPTY SPACES
The plan and the model will be accompanied by the design tool of the section. Longitudinal and cross sections will be requested not only as a verification of the project but as a further tool for understanding the relationship between the project and the assigned area, between its built parts and the voids generated. Also in this phase will be required the realization of a study model (physical scale 1,200 or 3D).
(2 weeks)
THE GROUND LEVEL
The delicate relationship between the building and the city will be deepened in the development of the ground floor plan with particular attention to the spatial relationships between public space, collective outdoor and indoor space, access system and distribution. Also in this phase, an update of the previous projects will be required. (2 weeks)
FACING THE CITY
The project of the elevations will be guided by the planimetric organization and its module and by the relationships that the building establishes with its context. A focus on facade technology will be shared with the technology teacher. In this last phase, an update of the previous projects will be requested and further specific materials will be defined for each single project. (2 weeks)
FINAL PHASE
In the final phase, where necessary, redesign and re-editing of previously processed materials and the creation of a “manifesto” image or final model will be required.
In each of the exercises, as well as in the final re-elaboration, the individual student and the group are always allowed to return to their previous choices on the basis of new hypotheses that emerged in the project exploration.
Sintesi degli argomenti trattati, copia delle slides usate durante le lezioni e documenti utili all'organizzazione delle attività dei gruppi verranno resi disponibili sul portale della didattica.
Nel corso dell'atelier, il docente fornirà diversi riferimenti bibliografici, si richiama intanto la bibliografia di base:
Zevi B. (1948), Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura, Einaudi, Torino
Abalos I. (2001), Il buon abitare, pensare le case della modernità. Marinotti: 2009.
Davis C. (2011), Il primo libro di architettura, Einaudi, Torino
Leonardi C., Stagi F. (2018), L’architettura degli alberi, Lazy Dog
E' inoltre indispensabile che gli studenti consultino con costanza le principali riviste di architettura (a titolo di esempio: Casabella, Domus, Lotus, El Croquis, The Plan, The Architectural Review ecc.).
di esempio
Summary of the topics covered, copies of the slides used during the lessons and documents useful to the organization of the activities of the groups will be made available on the web site "portale della didattica".
During the course of the workshop, the teacher will provide various bibliographical references. Below are the texts of the basic bibliography:
AA. VV. (2004), Alison and Peter Smithson, From the house of the future to the house of today, 010 Publishers.
AA.VV. (2018), L’architettura degli alberi, Lazy Dog.
Abalos I. (2001), The good life, a guided visit to the houses of modernity. Park Books.
Balmond C. (2002), Informal. Munich: Prestel Verlag.
Banham R. (1971), Los Angeles, The architecture of four ecologies. Harper & Row.
Koolhaas R. (1995), SMLXL, The Monacelli press: New York.
Le Corbusier (1923), Vers une architecture, Cres.
Loos, A. (1962) Ins Leere gesporochen Trotzdem. Verlag Herold.
Rossi A. (1978), L'architettura della città. Milano: CittàStudiEdizioni.
Slides; Dispense; Materiale multimediale ;
Lecture slides; Lecture notes; Multimedia materials;
Modalità di esame: Prova orale obbligatoria; Elaborato progettuale individuale; Elaborato progettuale in gruppo;
Exam: Compulsory oral exam; Individual project; Group project;
...
Lo studente riceve un feedback continuo dal docente sul proprio avanzamento grazie alle revisioni in laboratorio delle proprie elaborazioni personali e di gruppo.
L’esame si svolge attraverso una sintetica discussione del percorso di progetto individuale, supportata dalla esposizione dei diversi materiali anche intermedi prodotti dallo studente nel corso dell'atelier.
La valutazione terrà conto dei seguenti aspetti, valutati in base agli elaborati finali ed intermedi prodotti, individuali e di gruppo, così pesati nella valutazione finale:
- Capacità di interpretare e proporre configurazioni spaziali e distributive, 30%
- Capacità di interpretare il contesto di intervento, 20%
- Capacità di interpretare e proporre forme strutturali e sistemi costruttivi, 20%
- Qualità della rappresentazione e comunicazione, 30%
Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
Exam: Compulsory oral exam; Individual project; Group project;
Il risultato sintetico del lavoro consiste nei due modelli di studio realizzati nel corso delle quattro esercitazioni, un album di disegni e una presentazione in PDF contentente tutti i materiali sviluppati nel corso dell'atelier. L'esame consisterà in una presentazione finale individuale e di gruppo.
Modalità di valutazione
Lo studente riceve un feedback continuo dal docente sul proprio avanzamento grazie alle revisioni in laboratorio delle proprie elaborazioni personali e di gruppo.
L’esame si svolge attraverso una sintetica discussione del percorso di progetto individuale, supportata dalla esposizione dei diversi materiali anche intermedi prodotti dallo studente nel corso del laboratorio.
La valutazione terrà conto dei seguenti aspetti, valutati in base agli elaborati finali ed intermedi prodotti, individuali e di gruppo, così pesati nella valutazione finale:
· Capacità di interpretare e proporre configurazioni spaziali, 20%
· Capacità di interpretare e proporre configurazioni distributive, 20%
· Capacità di interpretare e proporre forme strutturali, 20%
· Capacità di interpretare e proporre sistemi costruttivi, 20%
· Qualità della rappresentazione e comunicazione 20%
In addition to the message sent by the online system, students with disabilities or Specific Learning Disorders (SLD) are invited to directly inform the professor in charge of the course about the special arrangements for the exam that have been agreed with the Special Needs Unit. The professor has to be informed at least one week before the beginning of the examination session in order to provide students with the most suitable arrangements for each specific type of exam.