Elenco notifiche

Caricamento in corso...
Principi di progettazione ambientale
01SUBPM
A.A. 2024/25
Lingua dell'insegnamento
Italiano
Corsi di studio
Corso di Laurea in Architettura - Torino
Organizzazione dell'insegnamento
| Didattica | Ore |
|---|---|
| Lezioni | 60 |
Docenti
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Filippi Francesca | Professore Associato | CEAR-08/C | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Collaboratori
Espandi
Riduci
Riduci
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennacchio Roberto | Collaboratore Esterno | 40 | 0 | 0 | 0 |
Didattica
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari | ICAR/12 | 6 | C - Affini o integrative | A11 |
|---|
2024/25
Obiettivo dell'insegnamento è l’acquisizione di consapevolezza critica riguardo i riferimenti culturali, gli obiettivi, i metodi, le tecniche e gli strumenti, le soluzioni progettuali per i sistemi insediativi, con particolare attenzione al modello di relazione uomo-ambiente, al centro della disciplina della "Progettazione Tecnologica Ambientale".
Centrali sono gli aspetti del rapporto tra progetto di architettura e tecnologia: l’attenzione al contesto, al clima e alle sue caratteristiche specifiche (ambientali, socio-culturali, economiche); il fattore umano e la sostenibilità di sistemi e processi; l'uso razionale ed efficiente dell'energia e delle risorse; la prevenzione delle vulnerabilità dell'ambiente costruito.
Il rapporto tecnica/forma è indagato con uno sguardo attento al rapporto tra tradizione e innovazione alle varie scale del progetto, da quella urbana a quella di prodotto, dalle comunità in via di sviluppo a quelle avanzate.
Attenzione specifica è data all'adaptive design e all'usability, nonché alla definizione di strumenti, metodologie, soluzioni progettuali per la raccolta, l’elaborazione e il monitoraggio dei dati tecnologici e ambientali.
The aim of the course is the acquisition of critical awareness about cultural references, objectives, methods, techniques and tools, design solutions for settlement systems, with particular attention to the human-environment relationship model, at the center of the Design Environmental Technology.
The aspects of the relationship between architectural design and technology are central: attention to the context, climate and its specific characteristics (environmental, socio-cultural, economic); the human factor and the sustainability of systems and processes; the rational and efficient use of energy and resources; the prevention of vulnerabilities in the built environment.
The technical / form relationship is investigated with a careful look at the relationship between tradition and innovation at the various scales of the project, from urban to product, from developing to developed communities.
Specific attention is given to adaptive design and usability, as well as to the definition of tools, methodologies, design solutions for the collection, processing and monitoring of technological and environmental data.
Gli obiettivi di apprendimento attesi fanno riferimento a:
- la sostenibilità come approccio al progetto, a partire dalla conoscenza del contesto (ambientale, sociale, economico) fino alla definizione della forma, la scelta dei materiali e delle tecnologie costruttive;
- la concezione processuale dell’attività progettuale, a tutte le scale;
- l’appropriatezza delle tecnologie;
- il controllo bioclimatico e l’analisi del comfort adattativo in contesti caratterizzati da condizioni climatiche estreme o specifici vincoli.
Lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• saper identificare gli aspetti significativi del progetto, anche nel contesto della loro collocazione storica, urbana e ambientale;
• saper leggere e interpretare problemi complessi in maniera olistica, in un’ottica multidisciplinare e integrata, in particolare i problemi legati alla progettazione/trasformazione dell’ambiente naturale e costruito e alla qualità del fare architettura sia in rapporto alla risorsa ambiente che alla materia del costruire;
• acquisire un panorama chiaro dei metodi e delle tecniche sulla base delle loro funzioni e della appropriatezza;
• acquisire la capacità di pensiero critico sui temi della sostenibilità in architettura.
I risultati dell’apprendimento saranno verificati attraverso:
- la lettura, comprensione ed elaborazione critica dei contenuti, delle loro relazioni e implicazioni con uno sguardo multidisciplinare;
- la capacità di comunicare efficacemente e con un linguaggio appropriato i contenuti dell’apprendimento.
Expected learning objectives refer to:
- sustainability as an approach to the project, starting from the knowledge of the context (environmental, social, economic) up to the definition of the form, the choice of materials and construction technologies;
- the procedural conception of the project activity, at all scales;
- the appropriateness of technologies;
- bioclimatic control and adaptive comfort analysis in contexts characterized by extreme weather conditions or specific constraints.
The student must be able to apply the acquired knowledge to achieve the following objectives:
• be able to identify the significant aspects of the project, even in the context of their historical, urban and environmental location;
• being able to read and interpret complex problems in a holistic way, in a multidisciplinary and integrated perspective, in particular the problems related to the design / transformation of the natural and built environment and to the quality of making architecture both in relation to the environment resource and to the matter of build;
• acquire a clear overview of the methods and techniques based on their functions and appropriateness;
• acquire the capacity for critical thinking on issues of sustainability in architecture.
Learning outcomes will be verified through:
- reading, understanding and critical processing of the contents, of their relationships and implications with a multidisciplinary view;
- the ability to communicate the contents of learning effectively and with appropriate language.
Sono richiesti e date già per acquisiti: i principi di cultura tecnologica della progettazione; le conoscenze di base della tecnologia dell’architettura (approcco esigenziale-prestazionale, tecnologie e sistemi costruttivi, materiali/semilavorati/prodotti edilizi) e della fisica tecnica ambientale. E’ richiesta anche la conoscenza degli strumenti, dei metodi e dei codici di rappresentazione del progetto.
Prior knowledge is required of: the principles of technological design culture; the basic knowledge of architectural technology (demand-performance approach, building technologies and systems, materials / semi-finished / building products) and building physics. Knowledge of the tools, methods and representation codes of the project is also required.
I temi affrontati a lezione fanno riferimento a quattro ambiti principali: il contesto globale e il paradigma della sostenibilità (5 h); la progettazione bioclimatica (25 h), i materiali e le tecnologie appropriate (15 h), l'abitare e la relazione tra ambiente (naturale, costruito) e utente/occupante (15 h).
In particolare gli argomenti riguardano:
- Il paradigma della sostenibilità: il rapporto tra territorio, architettura e ambiente; gli indirizzi, le politiche internazionali, le istituzioni e gli attori a tutela dell'ambiente, della crescita economica e dell’equità sociale (Nazioni Unite, Banca Mondiale, etc.);
- sostenibilità e progettazione bioclimatica: progettazione bioclimatica, progettazione tecnologica per la riduzione dell'energia totale consumata. Cenni agli apparati di incentivo alla qualità ambientale del costruito e di indirizzo/valutazione/certificazione;
- Il rapporto tecnica/forma nel paesaggio costruito, le soluzioni morfologiche e tipologiche, la relazione con il luogo, il clima, le risorse ambientali e l’uomo, l’analisi, la definizione e il controllo delle tecnologie, delle tecniche e dei materiali per una ricerca di qualità dell’architettura in un’ottica di innovazione tecnologica, benessere e confort, compatibilità ambientale e eco-efficienza;
- l’architettura vernacolare: principi, soluzioni e tecniche costruttive. Esempi nei diversi climi;
- la riflessione e la definizione del ruolo sociale, culturale e tecnico dell’architetto, come responsabile delle trasformazioni fisiche dell’ambiente e dei processi che determinano la qualità del territorio e dello spazio per l’uomo.
- Low-tech e costruzione facilitata: Identificazione del rapporto progetto-tecnologia in funzione del basso costo/alta qualità - Analisi di procedimenti costruttivi finalizzati al contenimento del peso e dei consumi nelle fasi di costruzione, gestione e manutenzione, al recupero di risorse, all'impiego di maestranze disponibili, alla durata stabilita - Progettazione per la costruzione facilitata fino all'autocostruzione.
The topics covered in the lectures concern:
- The paradigm of sustainability: the relationship between territory, architecture and the environment; addresses, international policies, institutions and actors to protect the environment, economic growth and social equity (United Nations, World Bank, etc.);
- sustainability and bioclimatic design: bioclimatic design, technological design for the reduction of total energy consumed. Outline of incentive systems for the environmental quality of buildings and of address / evaluation / certification;
- The technical / form relationship in the built environment, the morphological and typological solutions, the relationship with the place, the climate, the environmental resources and the people, the analysis, the definition and the control of technologies, techniques and materials for a search for quality architecture in terms of technological innovation, well-being and comfort, environmental compatibility and eco-efficiency;
- vernacular architecture: principles, solutions and construction techniques. Examples in different climates;
- reflection and definition of the social, cultural and technical role of the architect, as responsible for the physical transformations of the environment and the processes that determine the quality of the territory and space for the people.
- Low-tech and facilitated construction: Identification of the project-technology relationship according to the low cost / high quality - Analysis of construction procedures aimed at limiting weight and consumption in the construction, management and maintenance phases, to the recovery of resources, to 'use of available knowledge and capacities, at the established duration - Design for the facilitated construction up to self-construction.

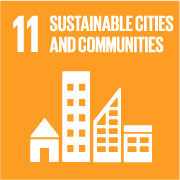


I principali strumenti didattici sono: lezioni frontali, integrate da attività seminariali (con esperti, operatori del settore, aziende produttrici, progettisti), approfondimento e discussione su specifici casi studio, esercitazioni progettuali e eventuali visite a siti significativi.
The main didactic tools are: lectures, supplemented by seminar activities (with experts, sector operators, manufacturing companies, designers), design exercises and visits to significant sites.
- Edward Allen, Come funzionano gli edifici, Edizioni Dedalo, Bari 2017;
- Donatella e Dennis Meadows, Jorgen Randers, I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio, Mondadori, Milano 2006;
- Lynne Elizabeth; Cassandra Adams (editors), Alternative Construction. Contemporary Natural Building Methods, Hoboken : John Wiley and Sons, 2005.
- Yona Friedman, Jon Goodbun (Guest Editor), Jeremy Till (Guest Editor), Deljana Iossifova (Guest Editor), Scarcity: Architecture in an Age of Depleting Resources, John Wiley and Sons,, 2012.
- Kent A. Harries; Bhavna Sharma, Nonconventional and Vernacular Construction Materials, Sawston : Woodhead Publishing, 2016.
- Cindy Harris; Pat Borer, The Whole House Book. Ecological Building Design and Materials, Machynlleth : Centre for Alternative Technology, 2005.
- Barrett Hazeltine; Lars Wanhammar; Christopher Bull, Appropriate Technology: Tools, Choices, and Implications, New York : Academic Press, 1999.
- Paul Gut, Dieter Ackerknecht, Climate responsive buildings, SKAT, 1993
- Andres Lepik, Small Scale, Big Change: New
Architectures of Social Engagement, MoMa, 2010
- Edward Mazria, The passive solar energy book. A complete guide to passive solar home, greenhouse, and building design, Emmaus, Pa. : Rodale Press, 1979.
- Gernot Minke, Building with Earth. Design and Technology of a Sustainable Architecture, Basel : Birkhäuser, 2006.
- Paul Oliver (editor), Encyclopaedia of vernacular architecture of the world, Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
- Paul Oliver, Built to Meet Needs. Cultural Issues in Vernacular Architecture, Oxford: Architectural Press, 2006.
- Victor Papanek, Design for the Real World. Human Ecology and Social Change, Frogmore : Paladin, 1974.
- Victor Papanek, The Green Imperative. Ecology and Ethics in Design and Architecture, London : Thames & Hudson, 1995
- Michael Reynolds, Earthship: How to Build Your Own, Taos : Solar Survival Press, 1990.
- Johan van Lengen, The barefoot architect. A Handbook for Green Building, Shelter, 2007.
- Cynthia E. Smith, Design for the Other 90%, New York : Smithsonian, 2007.
- Carole Ryan, Traditional Construction for a Sustainable Future, Abingdon : Spon Press, 2011.
Riviste di architettura (es. Detail, AZERO, The Plan, Lotus, Domus, Casabella, Arketipo, Il progetto sostenibile, Materia, Costruire in laterizio, etc)
Ulteriore bibliografia sarà comunicata a lezione dal docente titolare dell’insegnamento.
- Donatella e Dennis Meadows, Jorgen Randers, I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio, Mondadori, Milano 2006;
- Lynne Elizabeth; Cassandra Adams (editors), Alternative Construction. Contemporary Natural Building Methods, Hoboken : John Wiley and Sons, 2005.
- Yona Friedman, Jon Goodbun (Guest Editor), Jeremy Till (Guest Editor), Deljana Iossifova (Guest Editor), Scarcity: Architecture in an Age of Depleting Resources, John Wiley and Sons,, 2012.
- Kent A. Harries; Bhavna Sharma, Nonconventional and Vernacular Construction Materials, Sawston : Woodhead Publishing, 2016.
- Cindy Harris; Pat Borer, The Whole House Book. Ecological Building Design and Materials, Machynlleth : Centre for Alternative Technology, 2005.
- Barrett Hazeltine; Lars Wanhammar; Christopher Bull, Appropriate Technology: Tools, Choices, and Implications, New York : Academic Press, 1999.
- Paul Gut, Dieter Ackerknecht, Climate responsive buildings, SKAT, 1993
- Andres Lepik, Small Scale, Big Change: New
Architectures of Social Engagement, MoMa, 2010
- Edward Mazria, The passive solar energy book. A complete guide to passive solar home, greenhouse, and building design, Emmaus, Pa. : Rodale Press, 1979.
- Gernot Minke, Building with Earth. Design and Technology of a Sustainable Architecture, Basel : Birkhäuser, 2006.
- Paul Oliver (editor), Encyclopaedia of vernacular architecture of the world, Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
- Paul Oliver, Built to Meet Needs. Cultural Issues in Vernacular Architecture, Oxford: Architectural Press, 2006.
- Victor Papanek, Design for the Real World. Human Ecology and Social Change, Frogmore : Paladin, 1974.
- Victor Papanek, The Green Imperative. Ecology and Ethics in Design and Architecture, London : Thames & Hudson, 1995
- Michael Reynolds, Earthship: How to Build Your Own, Taos : Solar Survival Press, 1990.
- Johan van Lengen, The barefoot architect. A Handbook for Green Building, Shelter, 2007.
- Cynthia E. Smith, Design for the Other 90%, New York : Smithsonian, 2007.
- Carole Ryan, Traditional Construction for a Sustainable Future, Abingdon : Spon Press, 2011.
Architecture magazines (eg Detail, AZERO, The Plan, Lotus, Lotus, Domus, Casabella, Arketipo, Il progetto sostenibile, Materia, Costruire in laterizio, etc)
A further bibliography will be communicated in class by the professor. Lecture notes by the teacher will be provided during the course.
Slides; Esercizi; Strumenti di collaborazione tra studenti;
Lecture slides; Exercises; Student collaboration tools;
Modalità di esame: Prova orale obbligatoria; Elaborato grafico individuale; Elaborato grafico prodotto in gruppo;
Exam: Compulsory oral exam; Individual graphic design project; Group graphic design project;
...
La valutazione si compone di due parti: dei giudizi formulati durante lo svolgimento dell'insegnamento e dell’esame finale.
Alle fasi di valutazione in itinere sono dedicati momenti specifici per la presentazione dei materiali elaborati (individualmente o in piccoli gruppi) dagli studenti e i giudizi influenzano per il 30% il voto finale; concorrono al giudizio: la coerenza metodologica ovvero la qualità e organizzazione dei materiali elaborati e l’applicazione delle conoscenze e strumenti acquisiti durante il processo formativo ovvero la capacità di elaborazione, sintesi ed esposizione dei materiali presentati. Le esercitazioni/verifiche in itinere riguardano l’approfondimento di casi studio che affrontino il tema del rapporto tra tecnologia, ambiente, comunità.
L’esame è in forma orale, individuale, e consiste nella presentazione, da parte dello studente, degli approfondimenti (raccolti in un book) svolti durante l'insegnamento. Durante il colloquio verranno inoltre poste 2/3 domande in merito ai contenuti dell'insegnamento (lezioni, bibliografia, esiti esercitazioni).
Concorrono al giudizio:
- Capacità di analisi e deduzione critica dei temi emersi dal lavoro svolto (rapporto tecnica/forma, soluzioni morfologiche e tipologiche, relazione con il luogo, il clima, le risorse ambientali e l’uomo, definizione delle tecnologie, delle tecniche e dei materiali);
- la capacità di organizzazione ed elaborazione, verificata sulla qualità dei materiali elaborati (comunicazione e precisione delle informazioni alle diverse scale);
- l’esposizione dell’elaborato svolto, ovvero dei contenuti teorici e applicati;
- la capacità di analisi critica;
- qualità delle fonti bibliografiche (ovvero: le fonti bibliografiche utilizzate coprono in modo esaustivo ed aggiornato l’argomento di discussione? Sono rappresentative del dibattito nazionale e internazionale?).
L'attribuzione della lode avviene in presenza di una conoscenza profonda e solida dei contenuti dell'insegnamento (con riferimenti a letture e approfondimenti bibliografici), di una eccellente valutazione degli elaborati svolti in itinere, di una padronanza e appropriatezza di linguaggio nell'esporre gli argomenti.
Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
Exam: Compulsory oral exam; Individual graphic design project; Group graphic design project;
The evaluation consists of two parts: the evaluation during the course and the final exam.
At the ongoing evaluation stages specific moments are dedicated for the presentation of the materials elaborated by the students (in small groups, max 3 people) and the evaluation influence 40% of the final grade; contribute to the evaluation: the methodological coherence that is the quality and organization of the processed materials and the application of the knowledge and tools acquired during the training process or the ability to process, synthesize and display the materials presented. The ongoing exercises / verifications concern the deepening of case studies that address the issue of the relationship between technology, environmental quality of the built environment, architecture and form.
The exam is oral, individual, and consists in the presentation by the student of the work carried out during the course in the group, returned in graphic form and accompanied by a report. During the interview 2/3 questions will also be asked about the course contents (lessons, bibliography, exercise results).
They compete for evaluation:
- Ability to analyze and critically deduce the issues that emerged from the work carried out (technology/form relationship, morphological and typological solutions, relationship with the place, climate, environmental resources and people, definition of technologies, techniques and materials) ;
- the ability to organize and process, verified on the quality of the materials produced (communication and accuracy of the information at different scales);
- the exposition of the work done, of the theoretical and applied contents;
- the capacity for critical analysis;
- quality of bibliographic sources (ie: do the bibliographical sources used cover the topic of discussion in an exhaustive and updated way? Are they representative of the national and international debate?).
In addition to the message sent by the online system, students with disabilities or Specific Learning Disorders (SLD) are invited to directly inform the professor in charge of the course about the special arrangements for the exam that have been agreed with the Special Needs Unit. The professor has to be informed at least one week before the beginning of the examination session in order to provide students with the most suitable arrangements for each specific type of exam.