Architettura, risorse, ambiente: storie e progetti
01VNDPX
A.A. 2024/25
Lingua dell'insegnamento
Italiano
Corsi di studio
Organizzazione dell'insegnamento
| Didattica | Ore |
|---|---|
| Lezioni | 10 |
| Esercitazioni in aula | 20 |
| Tutoraggio | 17,5 |
Docenti
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Canella Gentucca
Architettura, risorse, ambiente: storie e progetti (Progettazione architettonica e urbana) |
Professore Associato | CEAR-09/A | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 |
|
Tosco Carlo Mario
Architettura, risorse, ambiente: storie e progetti (Storia dell'architettura) |
Professore Ordinario | CEAR-11/A | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 |
Collaboratori
Didattica
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|
2024/25
Il seminario introduce ad alcune delle principali questioni che una rinnovata attenzione al rapporto tra architettura, risorse naturali, ambiente e paesaggio (rapporto da sempre costitutivo dell’agire architettonico) ha recentemente riportato al centro, tanto del progetto di architettura, quanto delle storie dell’architettura e del territorio. L’emergere di paradigmi interpretativi legati alla nozione di antropocene o alla radicale messa in discussione della distinzione tra natura e cultura ha avuto importanti implicazioni, tanto per le discussioni sul ruolo del progetto nel mondo contemporaneo, quanto per una rilettura complessiva del rapporto tra architettura, tecnologia e società.
Il seminario affronta questi temi proponendo da un lato la lettura e la discussione di una bibliografia di riferimento proposta dai docenti, dall’altro l’analisi critica di una serie di esperienze progettuali e di ricerca che hanno contribuito a ridefinire il campo d’azione e gli strumenti dell’architettura alle diverse scale.
The seminar introduces some of the main issues that a renewed attention to the relationship between architecture, natural resources, landscape and the environment (a relationship that has always been constitutive of architectural action) has recently refocused, both in architectural design and in the histories of architecture and the territory. The issue of interpretative paradigms linked to the notion of the anthropocene or the radical questioning of the distinction between nature and culture has had important implications, both for discussions on the role of design in the contemporary world and for an overall reinterpretation of the relationship between architecture, technology and society.
The seminar addresses these issues by proposing, on the one hand, the reading and discussion of a reference bibliography proposed by the teaching staff, and on the other, the critical analysis of a series of design and research experiences that have contributed to redefining the scope and tools of architecture at different scales.
Gli studenti in questo seminario acquisiranno conoscenze sottese in particolare a:
- capacità di muoversi all’interno della storiografia specialistica sulle questioni legate al rapporto tra ambiente, territorio e architettura, con una particolare attenzione al tema del rischio naturale e antropico;
- capacità di giungere a una comprensione articolata del rapporto tra società contemporanea, trasformazione urbana e risorse;
- comprensione del difficile rapporto tra trasformazioni urbane (legate a esigenze in costante mutamento), sostenibilità culturale e consapevolezza dei temi trattati.
Lo studente deve possedere un'adeguata preparazione personale e conoscenze derivanti dal superamento degli esami di progettazione architettonica e storia dell'architettura previsti nei corsi di laurea triennale in architettura (classe L-17). In particolare, vengono richieste le seguenti competenze:
- Capacità di leggere e comprendere la storia dell’architettura, della città, del territorio e le trasformazioni dell’ambiente e del paesaggio
- Capacità di leggere, comprendere e interpretare i progetti di architettura alle diverse scale di definizione, così come definito dalla direttiva 85/384/CEE e relative raccomandazioni
- Capacità di utilizzare gli strumenti e le forme della rappresentazione e della comunicazione, anche multimediale, per descrivere approfonditamente problemi complessi o che richiedono un approccio multidisciplinare;
- Capacità di comprendere ed esprimersi nel linguaggio disciplinare dell’architettura.
Il Seminario comprenderà lezioni, discussioni, fasi di ricerca operativa e progettuali condotte direttamente dagli studenti, singolarmente o in gruppo, eventuali incontri con esperti esterni.
La sperimentazione didattica sarà orientata alla definizione delle sfide che caratterizzano il mondo in cui viviamo analizzate con una particolare attenzione alle questioni delle risorse e dell’ambiente che influenzano e caratterizzano l’architettura, le sue storie e i progetti.
L’orizzonte di fondo del seminario è il dibattito attuale relativo ai rapporti tra emergenza climatica, dissesto idrogeologico e impatto degli eventi naturali sugli insediamenti. Il seminario ha l’obiettivo di impostare la riflessione su una letteratura transdisciplinare di riferimento – che tenga conto dei diversi paradigmi scientifici interpretativi dei fenomeni – e su un lessico condiviso, per poi passare a una disamina di come il rapporto tra risorse, ambiente e contesti culturali sia fondativo di ogni trasformazione territoriale e architettonica.
Saranno individuati alcuni scenari di riferimento, in cui le variazioni ambientali e climatiche hanno condizionato le logiche di insediamento, e saranno studiati – secondo i metodi della storia dell’architettura e della composizione architettonica (ICAR/18 e ICAR/14) – i modelli culturali, le tecniche e i saperi che hanno circostanziato, in epoche e contesti diversi, il rapporto coevolutivo tra ambiente naturale e processi di antropizzazione, dalla scala territoriale (fondazione di nuovi sistemi insediativi, bonifiche, infrastrutture) a quella architettonica.
Si tratta quindi di verificare – partendo dall’emergenza ambientale, ma estendendo l’attenzione alle diverse relazioni tra rischi naturali, dinamiche demografiche e insediamento – l’idoneità della ricerca architettonica a concorrere strutturalmente, in un rapporto dialettico tra tradizione e modernità, alle politiche di prevenzione e al processo di ricostruzione, anche attraverso un confronto di esperienze progettuali significative per la loro capacità di corrispondere agli impianti tipologici affrontati nei diversi contesti di applicazione e dimostrative del rapporto tra funzionalità, scelte distributive e suscettibilità espressive dell’architettura.
La stessa attualità del tema (si veda in particolare la rassegna stampa degli ultimi anni), rende compatibile per le aree oggetto di studio l’adozione di funzioni in grado di assorbire al loro interno una complessità di comportamenti, capace di intervenire sulle questioni urbane e sullo stato di aree da adattare a nuove soluzioni distributive, a nuovi modelli abitativi, a nuovi rapporti di vita associata.
È fornita una bibliografia di riferimento, costruita su diversi percorsi disciplinari che si occupano – storicamente e progettualmente – del rapporto tra ambiente, clima, risorse e trasformazioni territoriali, che sarà strumento di base per le prime lezioni di inquadramento metodologico dei problemi. Seguiranno approfondimenti critici e progettuali mirati ai casi-studio selezionati.

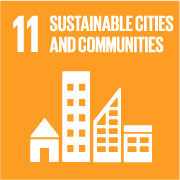


Il seminario prevede discussioni corali e consegne intermedie: si raccomanda, quindi, la frequenza. L'esercitazione di ogni singolo studente deve essere prodotta seguendo le scadenze date dal docente nel corso del semestre.
Il seminario è organizzato in moduli, ognuno dei quali si propone di fornire specifiche competenze e di introdurre a specifiche problematiche: ricerca bibliografica e discussione della letteratura esistente sono alla base di ogni riflessione.
Ogni modulo sarà oggetto di forme specifiche di revisione in forma individuale e contribuirà alla formazione della valutazione complessiva.
In occasione della prima lezione verrà consegnato un calendario dettagliato di promemoria dove la docenza indica con precisione le scadenze e i momenti di valutazione intermedia. Le esercitazioni verranno elaborate in piccoli gruppi e singolarmente.
È prevista una esercitazione interpretativa e progettuale finale – da sviluppare in piccoli gruppi (max due/tre persone) – connessa alle tipologie insediative poste in atto in contesti ambientali particolarmente soggetti a rischi naturali e antropici o previste a fronte delle calamità, anche attraverso l’utilizzo del montaggio e del confronto tipologico di casi studio significativi, indagando contestualmente motivazioni strutturali, tipi e morfologie, figurazione architettonica.
> Storia ambientale e storia del territorio: questioni di fonti e di metodo:
Marco Armiero, Stefania Barca, Storia dell’ambiente. Una introduzione, Carocci, Roma 2004
Gabriella Corona, Breve storia dell’ambiente in Italia, Il Mulino, Bologna 2015
Carlo Tosco, Il paesaggio come storia, Il Mulino, Bologna 2019
> Questioni di storia del clima e di periodizzazione globale di storia ambientale:
John R. McNeill e Peter Engelke, La Grande accelerazione. Una storia ambientale dell’Antropocene dopo il 1945, Einaudi, Torino 2018 (ed. orig. The Belkamp Press of Harvard University Press, 2014).
Wolfgang Behringer, Storia culturale del clima. Dall’era glaciale al riscaldamento globale, Bollati Boringhieri, Torino 2013 (ed. orig. Verlag C.H. Beck oHG, Munich 2010)
Emilio Padoa-Schioppa, Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l’Umanità, il Mulino, Bologna 2021.
> Approfondimenti di storia ambientale:
Adriano Prosperi, Tra natura e storia. Ambiente, economia, risorse in Italia, Donzelli, Roma 1996 e 20002
Adriano Prosperi, Demetra e Clio. Uomini e ambiente nella storia, Donzelli, Roma 2001.
Dossier Alla ricerca della storia ambientale, in “Contemporanea”, vol. 5, n. 1, gennaio 2002
> Per un approfondimento alla scala architettonica:
Barbabas Calder, Architecture. From Prehistory to Climate Emergency, Pelican 2021 (ora disponibile anche in traduzione italiana
Calamità naturali e strategie di ricostruzione, «Hinterland», n. 5-6, settembre - dicembre 1978
Domenico Chizzoniti (a cura di), Ricostruzione e città, «FAMagazine. Ricerche e progetti sull’architettura e la città», n. 55, 2021
Renato Capozzi e Claudia Pirina (a cura di), Forme del rito, forme dell'architettura, «FAMagazine. Ricerche e progetti sull’architettura e la città», nn. 57-58, 2021
Carlo Quintelli (a cura di), Architettura e città della salute: Luoghi e Centri di Salute Comunitaria, «FAMagazine. Ricerche e progetti sull’architettura e la città», n. 65, 2024
> Altre letture di contesto consigliate
Franz Fanon, I dannati della terra, Einaudi, Torino 1962 (ed. orig. 1961).
Fernand Braudel, Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Bompiani, Milano, 1977 (1985, 2020).
Silvia Omenetto, Migrazioni e (dis)continuità spaziale della morte, Tau Editrice, Todi 2020.
Slides;
Modalità di esame: Prova orale obbligatoria; Elaborato scritto individuale; Elaborato progettuale individuale; Elaborato progettuale in gruppo;
Exam: Compulsory oral exam; Individual essay; Individual project; Group project;
...
La valutazione sarà unica per entrambi i moduli del seminario.
Sarà così definita:
Il 50% della valutazione si basa sull’esito della prova orale, costituita da una domanda sul programma del seminario e sulla bibliografia di riferimento, unitamente alla discussione delle prove in itinere. Durata prevista del colloquio finale: 15 minuti.
Il 50% della valutazione si basa sull’esercitazione finale.
Nella prima parte del seminario saranno assegnate letture e brevi esercitazioni bibliografiche, da condurre in forma individuale, che verranno discusse in itinere e saranno presentate all’esame.
La seconda parte del seminario prevede un’esercitazione interpretativa e progettuale, da sviluppare in piccoli gruppi (due/tre persone), oggetto di revisione durante l'insegnamento e tema di discussione in sede di esame.
Sono previste scadenze intermedie che devono essere rispettate: in queste occasioni le esercitazioni in fieri saranno corrette dalla docenza e discusse in un seminario pubblico.
La valutazione finale è individuale e tiene conto anche delle revisioni e discussioni in itinere, delle valutazioni intermedie, della partecipazione individuale durante tutta la durata del seminario.
Il colloquio finale ha l’obiettivo di verificare le capacità acquisite: conoscenza della letteratura più specifica relativa ai temi della conoscenza del patrimonio territoriale e dell’ambiente, capacità critiche, capacità di scrittura scientifica e di elaborazione progettuale, capacità dialettica di esposizione di una problematica inerente il programma svolto in aula.
Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
