Elenco notifiche

Caricamento in corso...
Storia ambientale dell'architettura B
01VNZPX
A.A. 2024/25
Lingua dell'insegnamento
Italiano
Corsi di studio
Corso di Laurea Magistrale in Architettura Per La Sostenibilita' - Torino
Organizzazione dell'insegnamento
| Didattica | Ore |
|---|---|
| Lezioni | 20 |
| Esercitazioni in aula | 40 |
Docenti
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pace Sergio | Professore Ordinario | CEAR-11/A | 20 | 40 | 0 | 0 | 4 |
Didattica
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari | ICAR/18 | 6 | B - Caratterizzanti | Discipline storiche per l'architettura |
|---|
2024/25
L’offerta formativa della scuola d’architettura del Politecnico di Torino prevede, al I livello, un corso di storia dell’architettura contemporanea, un corso di storia dell’architettura moderna, un corso (opzionale) di storia dell’architettura medievale e un laboratorio di storia dell’architettura senza connotazione temporale.
All’inizio del II livello, il corso di "Storia ambientale dell’architettura" intende presentare la storia dell'architettura occidentale in una prospettiva inedita. Il suo punto di partenza giace in una considerazione oggettiva: l'architettura è un'invenzione dovuta all'abilità dell'uomo, vale a dire in buona parte alla sua capacità di scegliere e manipolare le risorse naturali a disposizione nei luoghi specifici. In tal modo, e in sintonia con gli obiettivi del corso di laurea in «Architettura per la sostenibilità», l'insegnamento prende in esame fonti, cronologie/periodizzazioni e oggetti di ricerca che possano al meglio far comprendere come sia stato costruito il rapporto tra ambiente naturale e ambiente antropizzato e/o costruito. Movendo lunga una linea del tempo di lunga durata, che troverà comunque i propri maggiori approfondimenti soprattutto nell'età contemporanea e nel tempo presente, il corso intende indagare come l'uomo abbia immaginato e costruito il proprio ambiente di vita all'interno - talvolta in sintonia, talvolta a scapito - dell'ambiente naturale circostante, con particolare attenzione nei confronti del clima, dello sfruttamento delle risorse naturali, del rapporto tra terre incolte, terre coltivate e aree abitate e/o urbanizzate.
The curriculum offered by the School of Architecture at the Politecnico di Torino provides, during the Bachelor's degree programme, a course in the history of contemporary architecture, a course in the history of modern architecture, an (optional) course in the history of medieval architecture and a workshop in the history of architecture with no time connotations.
At the beginning of the Master's degree programme, the "Storia Ambientale dell’Architettura" course aims to present the history of architecture from a brand new perspective. Its premise lies in a factual consideration: architecture is a human invention due mainly to man's ability to choose and manipulate the natural resources available in a given site. In this way, and following the goals of the curriculum in «Architettura per la Sostenibilità», the course explores sources, chronologies/periods and objects of research that may, at best, provide an insight into the relationship between the natural and artificial and built environment. Lessons will move along a long-term timeline, albeit it will find its most in-depth focus mainly in the contemporary and present age. It intends to investigate how people have designed and built their living environment, sometimes in harmony with and sometimes to the detriment of the surrounding natural environment. Special attention must be given to the climate, the exploitation of natural resources, and the relationship between uncultivated land, cultivated land and inhabited or urbanised areas.
Il corso di "Storia ambientale dell'architettura" intende offrire gli strumenti per sviluppare una duplice struttura conoscitiva.
La prima, di tipo ‘fattuale’, si concentra sull'analisi d’una serie di tematiche architettoniche e urbane, ritenute esemplari nella storia dell’ambiente naturale e costruito per caratteri, tecnologie, tipologie e repertori figurativi.
La seconda, di tipo ‘critico’, si concentra sull’analisi e sul confronto delle diverse interpretazioni che di tali fatti architettonici e urbani sono state, nel corso degli anni, prodotte dai numerosi attori sociali che hanno portato alla produzione e alla ricezione dell’ambiente costruito.
In questo modo, al termine del corso, allieve ed allievi dovranno essere in grado di muoversi tra due livelli di apprendimento: da un lato, occorrerà conoscere i fatti architettonici e urbani, mentre, dall'altro, occorrerà saper ricostruire la loro contestualizzazione storica e/o critica, lungo un ampio spettro temporale e attraverso una pluralità di voci. In altri termini, a completamento della propria formazione nelle scienze umane, occorrerà essere in grado di dimostrare più abilità intellettuali, costruite in parallelo: la conoscenza e la gerarchizzazione dei fatti storici, ma anche la capacità di riuscire a definirne e/o distinguerne i rispettivi valori simbolici e figurativi, e, infine, la capacità nel produrne altri, costruiti sulla consapevolezza del passato ma adatti a dar forma al presente.
Come parte integrante nella formazione umanistica, il corso punta ad accrescere la consapevolezza degli studenti nei confronti degli strumenti analitici, critici e speculativi, prodotti dalle culture architettoniche e/o a loro destinate. Tre sono gli obiettivi principali, dal punto di vista di conoscenze, abilità e competenze.
Innanzitutto, attraverso la lettura delle fonti originali (testi & immagini), si punta alla comprensione della complessità dei processi, delle identità dei diversi attori e della molteplicità delle ragioni culturali (tecnologiche, economiche, sociali, politiche) che, in particolare tra XVIII e XIX secolo, hanno prodotto, da un lato, narrazioni e retoriche sulla Natura e sui suoi molteplici rapporti con l'azione umana e, dall'altro, progetti architettonici e strategie urbane che abbiano accompagnato o contrastato, più o meno consapevolmente, quei discorsi.
in secondo luogo, si punta alla costruzione di un lessico di parole e immagini chiave, che consenta la comprensione e linterpretazione dei fenomeni di trasformazione e cura dell'ambiente naturale e/o costruito, nella lunga durata della storia occidentale, al fine di poter restituire una sintesi di alcune vicende specifiche in forma orale, scritta e/o grafica.
Infine, si punta alla costruzione di una serie di competenze specifiche, nella lettura e nella rappresentazione (verbale e/o grafica) dell'architettura, della città e del paesaggio, come fenomeni storicamente identificabili in un tempo e in un luogo, che hanno dato luoghi a veri e propri cortocircuiti: naturale/artificiale, città abitata / campagna coltivata, paesaggio agrario / paesaggio urbano.
Così, al termine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di dimostrare almeno tre qualità intellettuali, costruite in parallelo: la conoscenza dei fatti architettonici e urbani; la capacità di riuscire a distinguerne le varie interpretazioni, prodotte lungo un ampio spettro temporale e attraverso una pluralitࠤi voci; infine, l'abilità nel produrne altre, nuove e originali.
Una buona cultura storica, che abbia l’ambiente naturale e costruito al centro della propria narrazione, è il prerequisito indispensabile per affrontare il corso. Si danno, infatti, per acquisite non soltanto le conoscenze scolastiche basilari e le competenze apprese durante i corsi sia di storia dell’architettura sia di teoria e storia del restauro, ma anche le capacità di lettura e interpretazione dei fenomeni architettonici e urbani, maturate durante gli atelier multidisciplinari di progettazione, seguiti nei corsi di studio di I livello.
Per far sì che il corso si svolga non soltanto attraverso le lezioni ex cathedra, ma anche attraverso gli incontri seminariali, un prerequisito importante è dato dall'ottima predisposizione al dialogo, al dibattito, anche allo scontro di idee, maturato su un'attenta capacità di osservazione delle immagini e interpretazione dei dati a disposizione.
Infine, una conoscenza passiva della lingua inglese è certamente benvenuta e potrà essere messa a frutto, pur non costituendo un prerequisito obbligatorio.
Una buona cultura storica, che abbia lambiente costruito al centro della propria narrazione, 蠩l requisito indispensabile per affrontare il corso. Si danno, infatti, per acquisite non soltanto le conoscenze basilari e le competenze apprese durante i corsi di Storia dellarchitettura contemporanea, Teoria, storia e tecnica del restauro e Storia dellarchitettura moderna, ma anche le capacitࠤi lettura e interpretazione dei fenomeni architettonici e urbani, maturate durante gli atelier multidisciplinari di progettazione, seguiti nei corsi di studio di I livello.
Il calendario del corso prevede quattordici incontri durante il secondo periodo didattico, tra le 8.30 e le 13.00, avendo quindi a disposizione 4,5 ore di lezione.
In virtù di tale configurazione, e di là da brevi intervalli, ogni incontro è suddiviso in tre parti, ognuna della durata di un’ora e mezza, destinate ad attività diverse che scorrono in parallelo:
- 8.30-10.00: prima serie di lezioni
- 10.00-11.30: seminario di discussione
- 11.30-13.00: seconda serie di lezioni
Durante ciascun incontro, e al solo fine di distinguere i programmi d'esame, è fatto un appello per registrare i nomi degli studenti che stanno frequentando il corso: un massimo di quattro assenze è tollerato per rientrare in questa categoria.
Il programma del corso si articola in sezioni tematiche intercomunicanti, cui è dato un peso percentuale non identico, in termini di orario:
1. Le origini anti-naturalistiche dell'architettura occidentale --> 5%
2. L'invenzione della Natura nell'arte e nella letteratura del XIX secolo --> 10%
3. La costruzione dell'idea, dei discorsi e delle retoriche sulla sostenibilità ecologica, tra XIX e XXI secolo --> 10%
4. La questione dei paesaggi: agrario, naturale, artistico, culturale etc. --> 30%
5. Casi di studio --> 10%
A ciascuna di queste sezioni tematiche corrisponde un'esercitazione da sviluppare in aula, in presenza o da remoto, che andrà a far media in vista del voto finale d'esame.


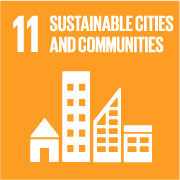
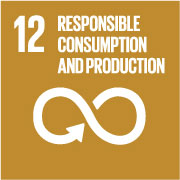
Tenendo presente il programma suddetto, gli argomenti affrontati nella prima serie di lezioni sono desunti dai due libri di testo principali, riportati di seguito in bibliografia, e vale a dire _Dalla caverna alla casa ecologica. Storia del comfort e dell’energia_, di Federico M. Butera, e _Architettura ed energia. Dalla preistoria all’emergenza climatica_, di Barnabas Calder.
Le architetture esaminate in maggior dettaglio nella serie di incontri seminariali sono desunte dai repertori canonici della storia dell'architettura dell'età contaemporanea, tra XIX e XXI secolo. In questa seconda parte è richiesto di dar luogo, in forma seminariale, a vere e proprie "dissezioni architettoniche", attraverso un duplice esercizio sia di identificazione delle cronologie e dei possibili autori e committenti dell'opera, sia di lettura e interpretazione integrale delle parti, in particolare legate alle questioni ambientali che possono esserre intravise sia nel rapporto con l'esterno sia nella disposizione degli interni, attraverso un campionario di immagini e letture di volta in volta messo a disposizione.
Infine, gli argomenti affrontati nella seconda serie di lezioni sono desunti dalle letture supplementari indicate in bibliografia, nel tentativo di approndire una serie di temi cruciali, riguardanti la storia ambientale in senso lato, in particolare tra gli albori dell'età contemporanea e il tempo presente.
Come da programma, il corso si articola in cinque sezioni tematiche, svolte in massima parte attraverso lezioni ex cathedra, cui fanno seguito brevi esercitazioni in aula, reale o virtuale che sia.
*Libri di testo*
- Federico M. Butera, _Dalla caverna alla casa ecologica. Storia del comfort e dell’energia_, II ed., Milano: Edizioni Ambiente, 2021
- Barnabas Calder, _Architettura ed energia. Dalla preistoria all’emergenza climatica_, Torino, Einaudi, 2022 [London: Penguin Press, 2021]
*Letture supplementari*
- Marco Armiero, Stefania Barca, _Storia dell’ambiente. Una introduzione_, Roma: Carocci, 2004, capp. «Storia» (pp. 19-82) e «Risorse» (pp. 127-165).
- Dipesh Chakrabarty, _Il clima della storia: quattro tesi_, in Id., _Clima, storia e capitale_, Milano: Nottetempo, 2021, pp. 49-96 [«Critical Inquiry», vol. 35, n. 2, 2009]
- Adrian Forty, _Parole e edifici. Un vocabolario per l’architettura moderna_, Bologna: Pendragon, 2004 [London: Thames & Hudson, 2000], cap. «Natura» (pp. 226-247)
- J. R. McNeill, Peter Engelke, _La grande accelerazione. Una storia ambientale dell'Antropocene dopo il 1945_, Torino: Einaudi, 2018 [Cambridge, Mass.: Belknap Press, 2014], cap. «Città ed economia» (pp. 97-144)
- Simone Neri Serneri, _Incorporare la natura. Storie ambientali del Novecento_, Roma: Carocci, 2005, capp. «Governare le acque urbane» (pp. 126-144) e «Acque per le industrie, acque per la città» (pp. 163-186).
- Paolo Portoghesi, _Natura e architettura_ Skira: Ginevra-Milano, 1999, pp. 9-71.
- Peter Sloterdijk, _Il rimorso di Prometeo. Dal dono del fuoco al grande incendio del pianeta_, Venezia: Marsilio, 2024 [Berlin: Suhrkamp, 2023], cap. «Il mito della libertà e la civiltà pirotecnica» (pp. 23-40)
- Ben Wilson, _Metropolis. Storia della città, la più grande invenzione della specie umana_, Milano: Il Saggiatore, [New York: Vintage, 2021], cap. «Megacittà. Lagos» (pp. 437-480)
*Lettura complementare*
- Amitav Gosh, _La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile_, Vicenza: Neri Pozza, 2017 [Chicago: University of Chicago Press, 201-66
Il testo di riferimento essenziale per la storia dell'architettura contemporanea è nei due volumi di Marco Biraghi, _Storia dell’architettura contemporanea I 1750-1945_ e _Storia dell’architettura contemporanea II 1945-2008_, Torino: Einaudi, 2008.
Il testo di riferimento essenziale per la storia della città contemporanea è di Donatella Calabi, _Storia della città : l'età contemporanea_, Venezia: Marsilio, 2005.
Testi di riferimento generale per la storia dell'architettura, dell'ambiente e del paesaggio sono:
- Bevilacqua P., _Demetra e Clio : uomini e ambienti nella storia_, Roma : Donzelli, 2001
- Butera F.M., _Dalla caverna alla casa ecologica : storia del comfort e dell'energia_, Milano : Ambiente ; 2007
- Fargione D., Concilio C., _Antroposcenari: Storie, paesaggi, ecologie_, Bologna: il Mulino, Spa ; 2018
- Jakob M., _Il paesaggio_, Bologna : Il mulino, 2009
- McNeill J.R., Engelke P., _La grande accelerazione : una storia ambientale dell'Antropocene dopo il 1945_, Torino : Einaudi, 2018
- Sereni E., _Storia del paesaggio agrario italiano_, Roma - Bari : Laterza, 1996.
Indicazioni bibliografiche specifiche sono per ciascuna lezione del corso.
Slides;
Lecture slides;
Modalità di esame: Prova orale obbligatoria;
Exam: Compulsory oral exam;
...
Al termine del corso sarà richiesto a tutte/i di sostenere una prova orale obbligatoria.
Coloro che avranno frequentato con assiduità il corso e, pertanto, avranno partecipato ad almeno dieci dei seminari in aula dovranno rispondere a tre domande. Oggetto delle discussione saranno tutti gli argomenti trattati sia durante le lezioni sia durante i seminari: sarà pertanto indispensabile far tesoro degli appunti presi in aula, da portare con sé all'esame, sempre tuttavia avendo i testi segnalati in bibliografia quale riferimento a sostegno della preparazione.
Coloro che NON avranno frequentato con assiduità il corso e, pertanto, NON avranno partecipato ad almeno dieci dei seminari in aula dovranno rispondere in forma orale a sei domande: tre saranno desunte dai libri di testo, mentre le altre tre saranno desunte dalle letture supplementari, che sono state traccia delle lezioni in aula.
Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
Exam: Compulsory oral exam;
Coloro che hanno frequentato con assiduità il corso e, pertanto hanno portato a termine entro le scadenze assegnate l'esercitazione prevista dovranno:
- presentare i risultati del proprio lavoro in un paper, la cui esposizione orale sarà di max 10 minuti
- rispondere in forma orale a due domande, volte ad accertare la dimestichezza del candidato con i temi affrontati durante il corso e la relativa bibliografia.
Coloro che NON hanno frequentato con assiduità il corso e, pertanto, NON hanno portato a termine entro le scadenze assegnate l'esercitazione prevista dovranno:
- rispondere in forma orale a sei domande, volte ad accertare la dimestichezza del candidato con i temi affrontati durante il corso e la relativa bibliografia.
In addition to the message sent by the online system, students with disabilities or Specific Learning Disorders (SLD) are invited to directly inform the professor in charge of the course about the special arrangements for the exam that have been agreed with the Special Needs Unit. The professor has to be informed at least one week before the beginning of the examination session in order to provide students with the most suitable arrangements for each specific type of exam.