Elenco notifiche

Caricamento in corso...
Storia dell'architettura e della città A
01VPHPQ
A.A. 2024/25
Lingua dell'insegnamento
Italiano
Corsi di studio
Corso di Laurea Magistrale in Architettura Costruzione Citta' - Torino
Organizzazione dell'insegnamento
| Didattica | Ore |
|---|---|
| Lezioni | 20 |
| Esercitazioni in aula | 40 |
Docenti
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pace Sergio | Professore Ordinario | CEAR-11/A | 20 | 40 | 0 | 0 | 4 |
Didattica
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari | ICAR/18 | 6 | B - Caratterizzanti | Discipline storiche per l'architettura |
|---|
2024/25
L’offerta formativa della scuola d’architettura del Politecnico di Torino prevede, al I livello, un corso di storia dell’architettura contemporanea, un corso di storia dell’architettura moderna, un corso (opzionale) di storia dell’architettura medievale e un laboratorio di storia dell’architettura senza connotazione temporale.
All’inizio del II livello, il corso di "Storia dell’architettura e della città A" intende fornire un tassello che si ritiene mancante o, quanto meno, poco evidente, nonostante la sua straordinaria importanza culturale. Il cosiddetto lungo Ottocento, vale a dire quel periodo tra la metà del secolo XVIII e gli inizi del secolo XX, è uno snodo fondamentale per comprendere il passaggio tra età moderna e contemporanea. L’idea stessa di modernità è stata rielaborata in quegli anni, per poi diventare essenziale nelle strategie e nelle pratiche architettoniche e urbane successive, spesso fino al tempo presente.
Per questo motivo, obiettivo principale dell’insegnamento è comprendere la complessità di quei processi che, guidati da una molteplicità di attori (architetti, ingegneri, committenti pubblici e privati) e da un ampio spettro di motivazioni (tecnologiche, economiche, sociali, politiche), tra fine Settecento e inizio Novecento hanno prodotto architetture e città ancor’oggi in via di trasformazione, grazie alle attuali logiche di progetto architettonico e urbano.
The curriculum offered by the School of Architecture at the Politecnico di Torino provides, during the Bachelor's degree programme, a course in the history of contemporary architecture, a course in the history of modern architecture, an (optional) course in the history of medieval architecture and a workshop in the history of architecture with no time connotations.
At the beginning of the Master's degree programme, the "History of Architecture and the City A" course aims to provide an element deemed missing or, at least, not conspicuous despite its extraordinary cultural importance. The so-called long nineteenth century, i.e. the phase between the mid-eighteenth century and the beginning of the twentieth century, is a cornerstone for understanding the transition between the modern and contemporary ages. The whole idea of modernity was reworked in those years, eventually becoming essential in later architectural and urban strategies and practices, often up to the present day.
For this reason, the main objective of the course is to comprehend the complexity of those processes that, driven by a diversity of actors (architects, engineers, public and private clients) and by a wide range of motivations (technological, economic, social, political), between the end of the 18th century and the beginning of the 20th century produced architectures and cities that are still under transformation today, thanks to the current approaches in architectural and urban design.
Il corso di "Storia dell'architettura e della città A" intende offrire gli strumenti per sviluppare una duplice struttura conoscitiva.
La prima, di tipo ‘fattuale’, si concentra sull'analisi d’una serie di casi-studio architettonici e urbani, ritenutii esemplari nella storia dell’ambiente costruito del lungo Ottocento per temi, caratteri, tipologie e repertori figurativi.
La seconda, di tipo ‘critico’, si concentra sull’analisi e sul confronto delle diverse interpretazioni che di tali fatti architettonici e urbani sono state, nel corso degli anni, prodotte dai numerosi attori responsabili della produzione e della ricezione dell’ambiente costruito.
In questo modo, al termine del corso, allieve ed allievi dovranno essere in grado di muoversi tra due livelli di apprendimento: da un lato, occorrerà conoscere i fatti architettonici e urbani, mentre, dall'altro, occorrerà saper ricostruire la loro contestualizzazione storica e/o critica, lungo un ampio spettro temporale e attraverso una pluralità di voci. In altri termini, a completamento della propria formazione nelle scienze umane, occorrerà essere in grado di dimostrare più abilità intellettuali, costruite in parallelo: la conoscenza e la gerarchizzazione dei fatti storici, ma anche la capacità di riuscire a definirne e/o distinguerne i rispettivi valori simbolici e figurativi, e, infine, la capacità nel produrne altri, costruiti sulla consapevolezza del passato ma adatti a dar forma al presente.
Il corso ambisce a sviluppare una duplice struttura conoscitiva. La prima, ‘fattuale’, si concentra su
di una scelta di episodi architettonici e urbani in grado di esemplificare temi, problemi e nozioni
cruciali nella storia dell’ambiente costruito. La seconda, ‘critica’, analizza e confronta le diverse
interpretazioni che su tali fatti sono state prodotte lungo diverse epoche storiche e attraverso una
varietà di attori sociali coinvolti nella produzione e ricezione dell’ambiente costruito. Gli studenti
saranno in grado di distinguere tra questi due livelli di apprendimento: i fatti architettonici e urbani,
e la loro ricezione storica e/o critica, lungo un ampio spettro temporale e attraverso una pluralità di
voci. Nell’approfondire lo studio gli studenti saranno inoltre chiamati ad applicare le nozioni di
metodo storico apprese e ad interpretare una pluralità di materiali e fonti della storia
dell’architettura e della città.
Così, al termine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di dimostrare più qualità
intellettuali, costruite in parallelo: la conoscenza dei fatti architettonici e urbani, ma anche la
capacità di riuscire a distinguerne le varie interpretazioni, e, infine, l’abilità nel produrne altre,
nuove e originali.
Una buona cultura storica, che abbia l’ambiente costruito al centro della propria narrazione, è il prerequisito indispensabile per affrontare il corso. Si danno, infatti, per acquisite non soltanto le conoscenze scolastiche basilari e le competenze apprese durante i corsi sia di storia dell’architettura sia di teoria e storia del restauro, ma anche le capacità di lettura e interpretazione dei fenomeni architettonici e urbani, maturate durante gli atelier multidisciplinari di progettazione, seguiti nei corsi di studio di I livello.
Per far sì che il corso si svolga non soltanto attraverso le lezioni ex cathedra, ma anche attraverso gli incontri seminariali - le "dissezioni architettoniche" - un prerequisito importante è dato dall'ottima predisposizione al dialogo, al dibattito, anche allo scontro di idee, maturato su un'attenta capacità di osservazione delle immagini e interpretazione dei dati a disposizione.
Infine, una conoscenza passiva della lingua inglese è certamente benvenuta e potrà essere messa a frutto, pur non costituendo un prerequisito obbligatorio.
Una cultura storica di base e una buona familiarità con l’inglese scritto sono richiesti per affrontare
il corso. Inoltre si daranno per scontate le conoscenze e competenze apprese nei corsi di Storia
dell’architettura, sia contemporanea sia di età moderna, del corso triennale, e nei corsi che si
confrontano con la storia e la lettura critica dell’architettura, quali ad esempio “Teoria, storia e
tecnica del restauro” e gli atelier multidisciplinari di progettazione, seguiti nei corsi di studio di I
livello.
Una conoscenza passiva (lettura) del francese o di un’altra lingua europea (spagnolo, tedesco) è
certamente benvenuta e potrà essere messa a frutto, ma non è un requisito.
Il calendario del corso prevede quattordici incontri durante il primo peridodo didattico, ogni martedì tra le 8.30 e le 13.00, avendo quindi a disposizione 4,5 ore di lezione.
In virtù di tale configurazione e di là da brevi intervalli, ogni incontro sarà suddiviso in tre parti, ognuna della durata di un’ora e mezza, destinate ad attività diverse che scorrono in parallelo:
- 8.30-10.00: lezione di storia dell’architettura
- 10.00-11.30: dissezioni architettoniche
- 11.30-13.00: lezione di storia urbana
Durante ciascun incontro, e al solo fine di distinguere i programmi d'esame, sarà fatto un appello per registrare i nomi degli studenti che stanno frequentando il corso: un massimo di quattro assenze sarà tollerato per rientrare in questa categoria.
....


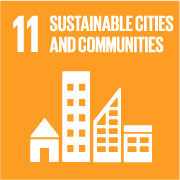
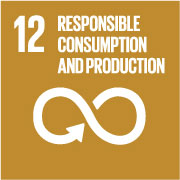
...
...
Tenendo presente il programma suddetto, gli argomenti affrontati nella prima serie di lezioni (storia dell'architettura) saranno la nozione di Eclettismo, il metodo Beaux-Arts, l'idea di tettonica, l'opera teorica della triade Semper / Viollet-Le-Duc / Ruskin, l’eccezione neogotica, il ruolo di Camillo Boito nella cultura architettonica italiana, le nuove costruzioni metalliche, le esposizioni nazionali e internazionali, l'idea paneuropea di stile nazionale e, infine, la costruzione storiografica che configurò i cosiddetti pionieri dell'architettura moderna.
Gli oggetti messi a confronto nella serie di “dissezioni architettoniche” saranno i Musei Vaticani vs la Bank of England, la Chapelle Expiatoire di Parigi vs il padiglione reale di Brighton, la Gliptoteca di Monaco di Baviera vs la sede dell’École des Beaux-Arts di Parigi, il British Museum vs l’Altes Museum, il Parlamento di Londra vs Palazzo Carignano a Torino, la Bibliothèque St. Geneviève vs il Crystal Palace, la All Saints Church vs il Museo di Oxford, l’Opéra vs la Bibliothèque Nationale di Parigi , la Mole antonelliana vs il Monumento a Vittorio Emanuele II di Roma, il Burgthater di Vienna vs l’Auditorium di Chicago, l’Hospital de la Santa Creu di Barcellona vs il Carson Pirie & Scott di Chicago, la Borsa di Amsterdam vs la Postsparkasse di Vienna, l’edificio sulla Michaelerplatz di Vienna vs il Woolworth Building di New York. In questa seconda parte è richiesto di dar luogo, in forma seminariale, a vere e proprie "dissezioni architettoniche", attraverso un duplice esercizio sia di identificazione delle cronologie e dei possibili autori e committenti dell'opera, sia di lettura e interpretazione integrale delle parti, attraverso un campionario di immagini e letture di volta in volta messo a disposizione.
Gli argomenti affrontati nella terza serie di lezioni (storia della città) saranno le forme e i limiti della città contemporanea, le teorie urbane, la crescita di reti e flussi all'interno dei tessuti urbani, la nascita di nuove attrezzature, la distinzione topografica e sociale tra luoghi del lavoro e luoghi dell'abitare, la nascita dei processi di decentramento urbano e, infine, la crescita dei luoghi dell'utile e della cura, con riferimenti monografici a casi-studio di rilievo (Londra. Vienna, Barcellona, Parigi, Milano, Letchworth, Nizza).
....
Testi obbligatori sono:
- Simonetta CIRANNA, Gerardo DOTI, Maria Luisa NERI, _Architettura e città nell'Ottocento. Percorsi e protagonisti di una storia europea_, Roma: Carocci, 2011.
- Guido ZUCCONI, _La città dell'Ottocento_, Roma-Bari: Laterza, 2001.
Ogni settimana, in aula e sul portale della didattica, saranno resi noti altri riferimenti bibliografici, indispensabili per contestualizzare e meglio comprendere le lezioni e i seminari.
...
Slides;
Lecture slides;
Modalità di esame: Prova orale obbligatoria;
Exam: Compulsory oral exam;
...
Al termine del corso sarà richiesto a tutte/i di sostenere una prova orale obbligatoria.
Coloro che avranno frequentato con assiduità il corso e, pertanto, avranno partecipato ad almeno dieci dei seminari in aula dovranno rispondere a tre domande. Oggetto delle discussione saranno tutti gli argomenti trattati sia durante le lezioni sia durante i seminari di "dissezione architettonica": sarà pertanto indispensabile far tesoro degli appunti presi in aula, da portare con sé all'esame, sempre tuttavia avendo i testi segnalati in bibliografia quale riferimento a sostegno della preparazione.
Coloro che NON avranno frequentato con assiduità il corso e, pertanto, NON avranno partecipato ad almeno dieci dei seminari in aula dovranno rispondere in forma orale a sei domande: tre saranno desunte dai due libri di testo obbligatori segnalati in bibliografia, mentre le altre tre saranno desunte dai testi indicati quale riferimento utile durante ciascun incontro seminariale e, quindi, resi noti sul portale della didattica.
Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
Exam: Compulsory oral exam;
Coloro che hanno frequentato con assiduità il corso e, pertanto, hanno portato a termine entro le scadenze assegnate l'esercitazione prevista dovranno:
- presentare i risultati del proprio lavoro in un paper, la cui esposizione orale sarà di max 10 minuti
- rispondere in forma orale a due domande, volte ad accertare la dimestichezza del candidato con i temi affrontati durante il corso e la relativa bibliografia.
Coloro che NON hanno frequentato con assiduità il corso e, pertanto, NON hanno portato a termine entro le scadenze assegnate l'esercitazione prevista dovranno:
- rispondere in forma orale a sei domande, volte ad accertare la dimestichezza del candidato con i temi affrontati durante il corso e la relativa bibliografia.
In addition to the message sent by the online system, students with disabilities or Specific Learning Disorders (SLD) are invited to directly inform the professor in charge of the course about the special arrangements for the exam that have been agreed with the Special Needs Unit. The professor has to be informed at least one week before the beginning of the examination session in order to provide students with the most suitable arrangements for each specific type of exam.