Elenco notifiche

Caricamento in corso...
Storia dell'architettura moderna
07CMKPM
A.A. 2024/25
Lingua dell'insegnamento
Italiano
Corsi di studio
Corso di Laurea in Architettura - Torino
Organizzazione dell'insegnamento
| Didattica | Ore |
|---|---|
| Lezioni | 60 |
| Tutoraggio | 10 |
Docenti
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornaglia Paolo - Corso 1 | Professore Associato | CEAR-11/A | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Cuneo Cristina - Corso 2 | Professore Associato | CEAR-11/A | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Piccoli Edoardo - Corso 3 | Professore Associato | CEAR-11/A | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Collaboratori
Espandi
Riduci
Riduci
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgassi Valentina - Corso 3 | Ricercatore L240/10 | CEAR-11/A | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Di Salvo Marco - Corso 2 | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Ferrari Marco - Corso 1 | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Ghoddousi Leone Carlo - Corso 3 | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 0 | 0 | 10 |
Didattica
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari | ICAR/18 | 6 | A - Di base | Discipline storiche per l'architettura |
|---|
2024/25
Insegnamento teso a fornire agli studenti della laurea triennale gli strumenti metodologici e le conoscenze per l’avvio dell’interpretazione storico-critica della storia dell’architettura in periodo moderno – dal XV al XVIII secolo – con particolare riferimento agli stati italiani, nel confronto con l’Europa. Nel definire tale quadro si intende prestare attenzione all’assetto politico-economico degli Stati e quindi alle geografie artistiche e alle principali committenze; al modificarsi del pensiero teorico e del mutare delle tecniche costruttive analizzando progetti e architetture ritenute esemplari. Lo studio dei diversi aspetti - architetto, forma, struttura, modelli, programmi, committenza, cantiere, contesto... - è articolato in tre parti, comuni a tutti gli insegnamenti e declinabili in modo leggermente diverso tra i vari docenti (vedi sotto: programmi).
Teaching aimed at providing the students with methodological tools and knowledge for the initiation of the historical-critical interpretation of Early Modern architectural history – from the fifteenth to the eighteenth century – with particular reference to the Italian states, in comparison with Europe. The course intends to focus on the political-economic structures of the states and thus on artistic geographies, systems of patronage, changes in theoretical thinking and construction techniques, by analyzing projects and some among the most significant buildings and sites. The study of the different aspects – architect, form, structure, models, programs, commissioning, construction site, context – is divided into three parts, common to all courses, with specific accents and different subtopics for each course (see below: programs).
I principali risultati di apprendimento attesi sono:
- conoscenza dei capisaldi della storia dell'architettura di età moderna; capacità di identificare correttamente e di collocare i diversi aspetti della produzione architettonica (edifici, progetti, testi) nel tempo e nello spazio, facendo uso di una terminologia adeguata;
- conoscenza degli strumenti di base dell'analisi storica in architettura;
- conoscenza e comprensione di alcune delle principali trasformazioni culturali, sociali, economiche e urbane del periodo e delle geografie considerate;
- capacità di base di identificare e utilizzare in modo corretto, incrociandole, le fonti per la storia dell'architettura;
The main expected learning outcomes are:
- General knowledge of architectural history and theory for the Early modern period; ability to correctly identify and place Early Modern architectural production in space and time, using an appropriate specific vocabulary.
- Knowledge of the methods of historical analysis in architecture.
- Knowledge and understanding of some of the cultural, social, economic urban transformations for the concerned period.
- Ability to identify historical sources and to use them correctly.
- Ability to organize and verify data collected through historical analysis, at different scales.
Una conoscenza generale della storia di età moderna, italiana ed europea, è prerequisito essenziale. Analogamente, l'insegnamento presuppone una conoscenza della storia dell'arte (a livello di scuola secondaria superiore) per la storia antica, medievale e moderna. Il posizionamento al secondo anno del corso di laurea, fa sì che si ritenga anche acquisito un vocabolario architettonico di base (parti di edifici, tipologie funzionali e costruttive, forme primarie nella storia dell'architettura, elementi di base della costruzione architettonica e dei materiali, linguaggio degli ordini architettonici, loro identificazione, nomenclatura delle loro parti costituenti).
A very general knowledge of Italian and European Early Modern history is a prerequisite. The course requires also a basic knowledge of Art history (at high school level) for the Ancient, Middle Ages and Early Modern periods. As the course is in the second year of the Bachelor Degree, a basic knowledge of the architectural vocabulary (parts of buildings, building types, building and construction elements, primary forms in the history of architecture) is also expected.
L'insegnamento si articola in tre parti principali, comuni e declinabili in modo leggermente diverso tra i diversi docenti:
1) Prof. Paolo Cornaglia
1. L’architettura del Quattrocento in Italia e i suoi rapporti con l’antico (15 ore)
• Il primo Rinascimento a Firenze: Filippo Brunelleschi
• Il rapporto tra architettura e natura nelle ville del Quattrocento a Firenze e il “giardino all’italiana”
• Leon Battista Alberti e la teoria dell’architettura
• Pienza e Urbino: progetto di città, residenza del principe e paesaggio
2. L’architettura del Cinquecento in Italia (20 ore)
• Bramante tra Milano e Roma
• Raffaello, Peruzzi e Sangallo e l’architettura di palazzo e di villa in Roma
• Michelangelo tra Firenze e Roma
• La fabbrica di San Pietro in Vaticano
• Palladio: le ville e l’architettura
3. La produzione architettonica del Seicento e del primo Settecento italiana ed europea (25 ore)
• Articolazione di un tipo: le ville romane di primo Seicento
• Il Barocco a Roma: Bernini
• Francesco Borromini
• Torino e Parigi: città capitali e residenze di corte
• Il giardino “alla francese”
• Guarini Guarini e il Barocco in Piemonte
• Filippo Juvarra e l’internazionalizzazione del Barocco
2) prof.ssa C. Cuneo
1. L’architettura del Quattrocento in Italia e i suoi rapporti con l’antico (20 ore)
• Filippo Brunelleschi, la cultura del cantiere gotico europeo e la nuova architettura fiorentina
• Il trattato di Vitruvio e la letteratura architettonica tra Quattrocento e Cinquecento
• Leon Battista Alberti
• Il sistema piazza-palazzo-chiesa a Pienza, Urbino e Vigevano
• Bramante a Milano
• La diffusione del linguaggio architettonico del Primo Rinascimento
2. L’architettura del Cinquecento in Italia (20 ore):
• Bramante e Giulio II a Roma, la lunga durata del cantiere di San Pietro in Vaticano
• Raffaello e l’età di Leone X
• Peruzzi, Sangallo e l’architettura di palazzo e di villa in Roma
• Michelangelo tra Firenze e Roma
• Dopo il sacco di Roma: Giulio Romano a Mantova e Sansovino a Venezia
• Il Concilio di Trento, l’architettura della Riforma cattolica a Roma e Milano
3. L’architettura del Seicento e del primo Settecento in Italia e in Europa (15 ore + 5 visita):
• Il primo Seicento a Roma, Maderno
• Bernini, Borromini e Pietro da Cortona
• Torino, Parigi e Madrid: città capitali e residenze di corte
• Committenze femminili e reggenze
• Guarino Guarini a Messina, Parigi e Torino
• Filippo Juvarra da Roma, a Torino a Madrid
3) Prof. Edoardo Piccoli
1. L’architettura del Quattrocento in Italia e i suoi rapporti con l’antico (15 ore)
2. L’architettura del Cinquecento in Italia (15 ore)
3. La produzione architettonica del Seicento e del Settecento italiana ed europea (30 ore)
The course is divided in three main parts, shared by all the professors but focusing more on some different topics
1) prof. Paolo Cornaglia
1. Italian architecture in the XVth century and its relationship with Antiquity (15 hours)
• Filippo Brunelleschi and the beginning of Renaissance in Florence
• The relationship among architecture, landscape and villas in Florence in the XVth century and the Italian garden
• Leon Battista Alberti and Theory of Architecture
• Pienza and Urbino: urban planning, princely residences and landscape
2. Italian architecture in the XVIth century (20 ore)
• Bramante in Milan and Rome
• Raffaello, Peruzzi, Sangallo: the architecture of palaces and villas in Rome
• Michelangelo in Florence and Rome
• Saint Peter in Vatican: plans, works, architects
• Palladio and his villas: the triumph of a type
3. Italian architecture in the XVIIth and XVIIIth cenury an d the European framework (25 hours)
• Roman villas at the beginning of the XVIIth century
• The birth of Baroque in Rome: Bernini
• Francesco Borromini
• Turin and Paris: capital cities and royal residences
• The French garden
• Guarini Guarini and the Baroque architecture in Piedmont
• Filippo Juvarra and the spread of Baroque all over Europe
2) Prof. Andrea Longhi
1. Quattrocento architecture in Italy and the relation with the Antique model (20 hours approx.):
- Filippo Brunelleschi, the culture of gothic building site and building process, and new architecture in Florence
- Vitruvius’ treaty and architectural literature between Quattrocento and Cinquecento
- Leon Battista Alberti
- Square, palace and church in Urbino, Pienza and Vigevano
- Bramante in Milan and Sforza patronage
2. The architecture of 16th century in Italy (20 hours approx.):
- Bramante and pope Giulius II in Rome; the long-lasting building-site of Saint-Peter in Vatican
- Raffaello, Peruzzi and architectures of villas and palaces in Roma
- Michelangelo in Florence and Rome
- Giulio Romano in Mantova and Sansovino in Venice
- Tridentine Council, architecture of Catholic Reform in Rome and Milan; Instructiones of Carlo Borromeo
- Vignola and Palladio: villas, palaces and churches, treatises and architectural orders in 16th c.
3. 17th and early 18th architecture in Italy and in Europe (20 hours approx.):
- early Seicento in Rome: Maderno
- Torino, the urban design of the capital-town and the structure of the State (Vitozzi, Castellamonte)
- historiography of baroque and relation with catholic counter-reformation and absolutism
- Bernini, Borromini and Pietro da Cortona
- Guarini Guarini in Europe, from Pars to Turin
- Filippo Juvarra, from Rome, to Turin and Madrid
3) Prof.sa Silvia Beltramo
1. Architecture of the Italian Quattrocento through the study of the works of the main architects and theorists of the Renaissance (25 CFU)
a. The Renaissance in Italy: art and architecture
b. The Renaissance in Florence: Filippo Brunelleschi
c. Leon Battista Alberti and the theory of architecture
d. The Italian urban “cities”: Ferrara, Urbino and Pienza
e. Francesco di Giorgio Martini: Urbino, Siena, military architecture and treaties
f. The Late Gothic in Northern Italy and the Renaissance in Milan: Solari and Filarete
2. Architecture of the XVI century in Italy (20 CFU);
a. Lorenzo il Magnifico in Florence: Giuliano da San Gallo
b. Donato Bramante from Milan to Rome
c. Rome in the first part of the XVI century: Raffaello, Peruzzi and Michelangelo
d. San Pietro in Vatican
e. Giulio Romano
f. Sansovino and Palladio
g. The Counter-Reformation, Mannerism and the order of the Jesuits
3. Architecture of the XVII-XVIII centuries in Italy and in Europe (15 CFU).
a. The Baroque in Rome: Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini and Francesco Borromini
b. The Baroque in Piedmont: Guarino Guarini
c. The Baroque in Piedmonte: Filippo Juvarra



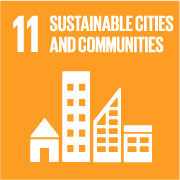
Per tutti gli insegnamenti, la frequenza alle lezioni è da intendersi come indispensabile alla buona riuscita dell’esame e al raggiungimento degli obiettivi formativi.
For all courses attending the lectures is essential to a good performance at the exam.
Prof. P. Cornaglia
L'insegnamento si articola in lezioni monografiche frontali (52 ore circa) eventuale partecipazione a convegni e seminari di interesse specifico che verranno segnalati agli studenti, sopralluoghi e visite a Palazzo Carignano e Stupinigi (8 ore circa ).
prof.ssa C. Cuneo
L’insegnamento si articola in lezioni monografiche frontali (35/40 ore) e lezioni a carattere partecipato, come flipped classroom e sperimentazione di valutazioni tra pari (20 ore) che verranno opportunamente presentate a inizio periodo didattico circa le modalità e criteri di valutazione. La valutazione delle lezioni partecipate contribuirà alla definizione del carico didattico per la prova finale. Le regole saranno esposte a inizio lezioni insieme al programma dettagliato delle attività. Verranno inoltre segnalati eventuali convegni e seminari di interesse specifico. Potranno essere previste lezioni di specialisti della disciplina su specifici temi. Se possibile, nel quadro delle vigenti normative, durante il periodo di lezioni saranno previste una o più brevi visite ad alcuni edifici sei-settecenteschi torinesi (5 ore).
Prof. E. Piccoli
L'insegnamento si articola in lezioni monografiche frontali (54 ore circa) eventuale partecipazione a esposizioni o seminari di interesse specifico che verranno segnalati agli studenti, sopralluoghi e visite (6 ore circa). Due esercitazioni, di cui una di analisi degli ordini architettonici, verranno assegnate durante l’anno; gli esiti verranno discussi in classe.
Prof. P. Cornaglia
The course is mainly based on classroom lectures (about 52 hours), with two open air lessons at Stupinigi Hunting Lodge and Venaria Reale Royal Palace (about 8 hours).
Prof.sa Silvia Beltramo e Andrea Longhi
The course is organized into lessons, structured by chronological periods (50 hs), and open air lessons in Turin within the ordinary course timetable are mandatory (10 hs.) if possible within the framework of national and local health regulations in force during the semester. Conferences and seminars of specific interest that will be reported to the students. Lessons by specialists in the discipline on specific topics may also be provided in accordance with other courses in the history of modern architecture.
Tra i molti testi disponibili, si consigliano, per un approccio generale alla materia:
- Storia dell’architettura in Italia. Tra Mediterraneo e Europa (VII-XVIII secolo), a cura di Alireza Naser Eslami e Marco Rosario Nobile, Pearson, Milano 2022 – Seconda parte
- Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, a cura di F. Paolo Fiore, Milano, Electa, 1998
- W. Lotz, Architettura in Italia 1500-1600, a cura di Deborah Howard, Milano, Rizzoli, 1997, 2002, seconda edizione
- R. Wittkower, Arte e Architettura in Italia 1600-1750, Torino, Einaudi, 1993; in particolare la parte seconda e terza
1) Prof. P. Cornaglia
Oltre ai quattro riferimenti generali:
a) Franco Panzini, Progettare la natura, Zanichelli, Bologna 2005, capitoli 5 & 6
b) Paolo Cornaglia, 1563-1798 tre secoli di architettura di corte. La città, gli architetti, la committenza, le residenze, i giardini in Enrico Castelnuovo, ( a cura di), La Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea, catalogo della mostra (Venaria Reale, 13 ottobre-31 marzo 2007), Allemandi, Torino 2007, pp. 117-184.
c) Paolo Cornaglia, Marco Ferrari, I giardini delle Residenze Sabaude: un solo sistema, in Paolo Cornaglia, Vincenzo Cazzato (a cura di), Viaggio nei Giardini d’Europa. Da Le Nôtre a Henry James, catalogo della mostra (Venaria Reale, 5 luglio-20 ottobre 2019), Edizioni La Venaria Reale, La Venaria Reale 2019, pp. 340-353.
Ulteriori riferimenti bibliografici e a websites per approfondimenti verranno dati durante lo svolgersi delle lezioni e saranno parzialmente disponibili sulla pagina del corso. Il materiale didattico proiettato a lezione sarà da subito a disposizione sul portale della didattica.
2) prof.ssa C. Cuneo
Letture per approfondimenti specifici, verranno consigliate nel corso delle lezioni; il materiale didattico proiettato a lezione sarà messo a disposizione, durante lo svolgimento delle lezioni, sul portale della didattica. Non avendo svolto l’insegnamento nel 2020, con la didattica da remoto e le relative registrazioni, la docente non dispone di video-lezioni da poter rendere disponibili.
3) Prof. E. Piccoli
Ulteriori riferimenti bibliografici e a siti verranno dati durante lo svolgersi delle lezioni e saranno parzialmente disponibili sulla pagina del corso. Il materiale didattico proiettato a lezione sarà via via messo a disposizione sul portale della didattica.
Among the many possible readings, the following are suggested as a first approach to the course topics:
- Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, ed. bu F. Paolo Fiore, Milano, Electa, 1998
- W. Lotz, Architettura in Italia 1500-1600, ed. by Deborah Howard, Milano, Rizzoli, 1997, 2002, 2nd ed.
- R. Wittkower, Arte e Architettura in Italia 1600-1750, Torino, Einaudi, 1993; especially parts 2 and 3
1) Prof. P. Cornaglia - Recommended readings
a) Franco Panzini, Progettare la natura, Zanichelli, Bologna 2005, chapters 5 & 6
b) Paolo Cornaglia, 1563-1798 tre secoli di architettura di corte. La città, gli architetti, la committenza, le residenze, i giardini in Enrico Castelnuovo, (ed. by), La Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea, exhibition catalogue (Venaria Reale, 13 October-31 March 2007), Allemandi, Torino 2007, pages. 117-184.
c) Paolo Cornaglia, Marco Ferrari, I giardini delle Residenze Sabaude: un solo sistema, in Paolo Cornaglia, Vincenzo Cazzato (eds), Viaggio nei Giardini d’Europa. Da Le Nôtre a Henry James, exhibition catalogue (Venaria Reale, 5 July-20 October 2019), Edizioni La Venaria Reale, La Venaria Reale 2019, pages. 340-353.
Powerpoint presentation will be available on the Polito website from the beginning of the course. Other suggestions concerning websites and readings will be offered during the course.
2) Prof. Andrea Longhi - Recommended readings
a) Paolo Cornaglia, 1563-1798 tre secoli di architettura di corte. La città, gli architetti, la committenza, le residenze, i giardini in Enrico Castelnuovo, ( a cura di), La Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea, catalogo della mostra (Venaria Reale, 13 ottobre-31 marzo 2007), Allemandi, Torino 2007, pp. 117-184.3)
3) Prof. Silvia Beltramo - Recommended readings:
J. S. ACKERMANN, La villa. Forma e ideologia, Einaudi, Torino 1992;
J. S. ACKERMANN, Palladio, Einaudi, Torino 1972;
A. BRUSCHI, Bramante, Laterza, Roma-Bari 1985;
E. FORSSMAN, Dorico, ionico, corinzio nell’architettura del Rinascimento, Laterza, Roma-Bari 1988;
R. WITTKOVER, Principi architettonici nell’età dell’umanesimo, Einaudi, Torino 1964;
J. SUMMERSON, Il linguaggio classico dell'architettura, Einaudi, Torino 1963.
Additional bibliography, references to websites, and readings are given throughout the course and will be partly available for download from the course website.
Slides; Dispense; Libro di testo;
Lecture slides; Lecture notes; Text book;
Modalità di esame: Prova scritta (in aula); Prova orale obbligatoria;
Exam: Written test; Compulsory oral exam;
...
La valutazione finale, individuale, si basa sull’accertamento di: (a) conoscenza di temi specifici nella storia dell’architettura moderna; (b) capacità di orientarsi nella periodizzazione e nella cronologia; (c) capacità di discutere di specifici casi (progetti, architetture, carriere di architetti) tra quelli analizzati.
1) Prof. Paolo Cornaglia
Esame scritto, durata 1.5 ore, non è consentito l’uso di materiale didattico
a) Riconoscimento di planimetria di edificio (presentata a lezione e presente sui powerpoint delle lezioni), con descrizione del manufatto, inquadramento cronologico e nell’opera dell’architetto (8/30)
b) Domanda in merito alla figura e all’opera di un architetto o di un tema (12/30)
c) Test di 11 domande con selezione delle risposte offerte (10/30)
2) prof.ssa C. Cuneo
La prova finale, individuale, sarà in forma orale (25/20 minuti ca), e articolata in alcune domande (3/4) volte a verificare le conoscenze acquisite. Sarà possibile, in caso di necessità, sostituire alla prova orale una prova scritta con 3 domande volte a verificare le conoscenze acquisite (durata 45 minuti). La valutazione finale si basa sull’accertamento di: (a) conoscenza di temi specifici nella storia dell’architettura moderna, 10/30; (b) capacità di orientarsi nella periodizzazione e nei collegamenti tra diversi episodi e temi, 10/30; (c) capacità di discutere di specifici casi (progetti, architetture, carriere di architetti) tra quelli analizzati, 10/30. La valutazione delle lezioni partecipate contribuirà alla definizione del carico didattico per la prova finale. Le regole saranno esposte a inizio lezioni con il programma dettagliato delle attività.
3) Prof. E. Piccoli
La prova finale, individuale, è in forma orale (durata 20/25 minuti ca), e articolata in alcune domande (3/4) volte a verificare le conoscenze acquisite. La valutazione finale si basa sull’accertamento di: (a) conoscenza di temi specifici nella storia dell’architettura moderna, 10/30; (b) capacità di orientarsi nella periodizzazione e nei collegamenti tra diversi episodi e temi, 10/30; (c) discussione di specifici casi (progetti, architetture, carriere di architetti), 10/30. Il buon esito delle esercitazioni realizzate durante l’anno potrà consentire di incrementare il voto finale di 1-2 punti.
Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
Exam: Written test; Compulsory oral exam;
E. Piccoli, A. Spila: La prova finale, individuale, sarà in forma orale (durata 20 minuti ca), e articolata in alcune domande (3/4) volte a verificare le conoscenze acquisite. La valutazione finale si basa sull’accertamento di: (a) conoscenza di temi specifici nella storia dell’architettura moderna, 10/30; (b) capacità di orientarsi nella periodizzazione e nei collegamenti tra diversi episodi e temi, 10/30; (c) capacità di discutere di specifici casi (progetti, architetture, carriere di architetti) tra quelli analizzati durante il corso, 10/30. Durante il corso si potranno proporre alcune esercitazioni (per es. sugli ordini architettonici) e letture, il cui buon esito, se verificato, potrà portare a una riduzione del programma di esame.
C. Cuneo: La prova finale, individuale, sarà svolta in forma orale (durata 20/25 minuti). Questa sarà articolata in alcune domande (3/4) volte a verificare le conoscenze acquisite. La valutazione finale si basa sull’accertamento di: (a) conoscenza di temi specifici nella storia dell’architettura moderna – 10/30; (b) capacità di orientarsi nella periodizzazione – 10/30; (c) capacità di riconoscere e discutere, attraverso le immagini, specifici esempi tra quelli analizzati durante il corso –10/30. E’ obbligatorio l’uso di immagini (preferibilmente su pc).
Una delle domande potrà essere riferita ad uno specifico approfondimento bibliografico concordato con la docenza. Ulteriori specificazioni e informazioni saranno fornite all’inizio del corso
In addition to the message sent by the online system, students with disabilities or Specific Learning Disorders (SLD) are invited to directly inform the professor in charge of the course about the special arrangements for the exam that have been agreed with the Special Needs Unit. The professor has to be informed at least one week before the beginning of the examination session in order to provide students with the most suitable arrangements for each specific type of exam.