Elenco notifiche

Caricamento in corso...
Scienza e tecnologia dei materiali
14CFRPM
A.A. 2024/25
Lingua dell'insegnamento
Italiano
Corsi di studio
Corso di Laurea in Architettura - Torino
Organizzazione dell'insegnamento
| Didattica | Ore |
|---|---|
| Lezioni | 60 |
Docenti
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janner Davide Luca - Corso 2 | Professore Associato | IMAT-01/A | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Montanaro Laura - Corso 3 | Professore Ordinario | IMAT-01/A | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Pagliolico Simonetta Lucia - Corso 1 | Ricercatore | IMAT-01/A | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Collaboratori
Espandi
Riduci
Riduci
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balagna Cristina - Corso 2 | Professore Associato | IMAT-01/A | 30 | 0 | 0 | 0 |
| D'Isanto Fabiana - Corso 2 | Ricercatore L240/10 | IMAT-01/A | 10 | 0 | 0 | 0 |
Didattica
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari | ING-IND/22 | 6 | C - Affini o integrative | A13 |
|---|
2024/25
L’insegnamento si propone di fornire i fondamenti tecnico-scientifici per una scelta consapevole ed un impiego responsabile dei materiali nel progetto architettonico, in quanto agli edifici e, conseguentemente, ai materiali con i quali sono realizzati sono richieste sempre nuove e complesse prestazioni, non solo strutturali, ma anche fisiche, di durabilità in esercizio, di sostenibilità economica ed ambientale, ecc. L’architetto, pertanto, pur non dovendo essere necessariamente un esperto in materiali, deve acquisire strumenti di dialogo con altre culture ed altri professionisti del mondo delle costruzioni, capacità affidabili di selezione dei materiali e del loro corretto impiego in architettura, sia per le nuove strutture che per la conservazione ed il restauro delle esistenti.
The teaching aims at supplying the technical-scientific fundamentals necessary for the correct choice and responsible use of building materials in architecture. Buildings, and consequently their constituent materials, are continuously requested to present new and more complex functionalities: both increased structural performances and better physical properties, durability, economic and environmental sustainability, etc. The Architect, therefore, should possess the proper tools to discuss with different cultures and professional roles in the construction field, should be able to properly select materials and correctly use them, both in new structures and in restoration and conservation projects.
L’insegnamento è finalizzato a fornire agli studenti appropriate conoscenze sulle principali classi di materiali di impiego comune nel mondo dell’architettura, nonché gli adeguati strumenti per poter comprendere la natura dei materiali stessi e saperla correlare alle loro principali proprietà chimiche, fisiche e meccaniche. L’insegnamento si propone inoltre di fornire un panorama dei materiali più comunemente impiegati nell’architettura, collegando le principali applicazioni alle loro prestazioni meccaniche e funzionali, con una particolare attenzione allo sviluppo di una adeguata consapevolezza nei confronti delle problematiche di degrado e deterioramento dei materiali per esposizione ad ambienti aggressivi, nonché dei criteri di sostenibilità economica ed ambientale. L’analisi dei principali materiali impiegati oggi nel campo dell’architettura costituirà un ulteriore strumento culturale e metodologico da applicarsi opportunamente ai futuri nuovi materiali, consentendone un impiego responsabile ed un’ottimale fruibilità.
The course is aimed at providing students the proper knowledge about the main materials used in architecture, as well as the proper tools to understand the material structure and correlate it with their main chemical, physical and mechanical properties.
The whole panorama of the mainly used materials in architecture will be given within the classes, by establishing meaningful properties-applications relationships. Particular attention will be paid to materials degradation phenomena due to environmental exposition. Basic knowledge about economic and environmental impact will be supplied. The analysis of the main materials used today in Architecture will provide a further cultural and methodological tool to be properly used for future, new materials, allowing their responsible use and optimal exploitation.
Nozioni di base di fisica, chimica e matematica sono utili per poter seguire e comprendere l’insegnamento in modo efficace. Vengono in ogni caso forniti, soprattutto nella prima parte della trattazione in aula degli argomenti dell’insegnamento, alcuni strumenti culturali di base necessari ad una fruizione attiva dei contenuti.
Rudiments of mathematics, chemistry and physics can be useful for an effective understanding of the course. In any case, in the frame of the first part of the program, basic concepts are provided to the students for a deeper fruition of the contents.
L’insegnamento, corrispondente a 6 CFU, é strutturato secondo il seguente programma:
- Parte 1: Introduzione alla Scienza e Tecnologia dei materiali (circa 2 crediti). In questa parte vengono illustrati la struttura, la composizione ed i criteri di classificazione dei materiali; segue la discussione delle principali proprietà dei materiali, dal punto di vista meccanico, fisico (densità, proprietà termiche, ottiche e acustiche) e chimico (interazione materiali con l’ambiente di esposizione);
- Parte 2: I materiali per l’architettura (circa 4 crediti). Saranno trattati i materiali leganti aerei e idraulici, quali gesso, calce aerea e idraulica, i cementi (portland, di miscela). Un particolare approfondimento viene quindi dedicato al calcestruzzo. Segue la trattazione dei materiali lapidei, dei materiali ceramici tradizionali, dei vetri, dei materiali metallici (un particolare approfondimento viene dedicato all’acciaio, ma verranno trattate anche la ghisa, le leghe di alluminio, rame, ecc.), del legno, dei materiali polimerici e dei materiali compositi. Per ciascuna classe di materiali la trattazione riguarda il ciclo produttivo, le proprietà, la durabilità, la sostenibilità ambientale nonché le possibili soluzioni tecnologiche finalizzate all’ottenimento di materiali caratterizzati dalle dovute prestazioni meccaniche e di durabilità.
The program of the course (6 CFU) is here detailed:
Part 1: Introduction to Material Science and Technology (about 2 CFU). The structure, composition and classification criteria of building materials are illustrated and discussed. Then, the main materials properties will be analysed on mechanical, functional (physical, thermal, optical and acoustic properties) and chemical (interaction with the environment and possible degradation phenomena) points of view.
Part 2: Materials for architecture (about 4 CFU). Building materials (aerial and hydraulic binders, such as gypsum, lime, hydrated lime, Portland and blended cements) will be analysed. Particular attention will be paid to concrete. Stones, traditional ceramics, glasses, metallic materials (mainly steel, but also cast iron and some other metal alloys – such as aluminium, copper and titanium alloys will be discussed), wood, polymeric and composite materials. For each class of materials, the processing (production and shaping), the properties, the durability, the environmental impact, the possible technological solutions to maximize the materials performance and durability will be explained.


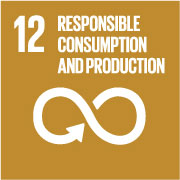
L’insegnamento è improntato unicamente sulla didattica frontale. È prevista la proiezione di filmati, per meglio illustrare alcune specifiche parti della materia trattata, l'uso di strumenti interattivi e possono essere previsti interventi seminariali tenuti da esperti dell’industria.
L’insegnamento è improntato unicamente sulla didattica frontale. È prevista la proiezione di filmati, per meglio illustrare alcune specifiche parti della materia trattata, l'uso di strumenti interattivi e possono essere previsti interventi seminariali tenuti da esperti dell’industria.
Lectures are provided. Films and videos will also be shown to deepen some aspects of the program; seminars by expert in the field will eventually be organized.
L’insegnamento è improntato unicamente sulla didattica frontale. E' prevista la proiezione di filmati, per meglio illustrare alcune specifiche parti della materia trattata, l'uso di strumenti interattivi e possono essere previsti interventi seminariali tenuti da esperti dell’industria.
The course is only based on ex-cathedra classes. Additionally, videos and interactive tools are used to deepen some aspects of the program; seminars by experts from the industry could be organized.
Testo principale di riferimento:
M. Gastaldi, L. Bertolini "Introduzione ai materiali per l’architettura", Città Studi Edizioni (2011).
Ulteriore bibliografia consigliata:
W.D. Callister, D.G. Rethwisch, Materiali per l'Ingegneria Civile ed Industriale, EdiSES (2023);
A. Negro, J.M. Tulliani, L. Montanaro, "Scienza e Tecnologia dei Materiali", Ed. Celid (2005);
M. Collepardi, Il Nuovo calcestruzzo, Ed. Tintoretto (2002);
J. F. Shackelford. Scienza e ingegneria dei materiali, Pearson Paravia Bruno Mondadori Editore (2009);
B. Berge. The ecology of building materials. Elsevier Architectural Press, Oxford (2009);
S. Pagliolico, R. Morra, Brevi cenni sulle proprietà chimiche e sull’elasticità dei materiali, Ed. Celid (2008);
S. Pagliolico, R. Morra, Il legno, Ed. Celid (2008).
Ulteriore materiale didattico potrà essere reso disponibile dal docente sul Portale della didattica.
M. Gastaldi, L. Bertolini "Introduzione ai materiali per l’architettura", Città Studi Edizioni (2011);
Other recommended readings:
Negro, J.M. Tulliani, L. Montanaro, "Scienza e Tecnologia dei Materiali", Celid (2001);
M. Collepardi, Il Nuovo calcestruzzo, Ed. Tintoretto (2002);
J. F. Shackelford. Scienza e ingegneria dei materiali, Pearson Paravia Bruno Mondadori Editore (2009);
B. Berge. The ecology of building materials. Elsevier Architectural Press, Oxford (2009);
S. Pagliolico, R. Morra, Brevi cenni sulle proprietà chimiche e sull’elasticità dei materiali, Ed. Celid (2008);
S. Pagliolico, R. Morra, Il legno, Ed. Celid (2008);
Slides; Video lezioni tratte da anni precedenti;
Lecture slides; Video lectures (previous years);
Modalità di esame: Prova scritta (in aula); Prova scritta in aula tramite PC con l'utilizzo della piattaforma di ateneo;
Exam: Written test; Computer-based written test in class using POLITO platform;
...
La prova scritta intende accertare l’apprendimento dei fondamenti teorici e degli aspetti applicativi dell’insegnamento, così come la capacità dello studente di valorizzarli ai fini della selezione consapevole dei materiali in architettura. L'esame intende inoltre accertare se lo studente ha acquisito gli strumenti di dialogo necessari per interloquire con i professionisti del settore.
DOCENTE: L. MONTANARO - L’apprendimento è valutato tramite una prova scritta in aula, della durata di 1h30’, nella quale sono proposte 10 domande a risposta aperta, a ognuna delle quali corrisponde una votazione massima di 3/30. L'eventuale "lode" è attribuita in relazione a risposte che uniscano, alla correttezza e completezza dei contenuti, chiarezza e rigore nella loro esposizione. Le domande, corredate eventualmente da grafici o tabelle già precompilate, si prefiggono di evidenziare la capacità maturata dai discenti nel restituire i concetti fondamentali della disciplina e la consapevolezza nell’affrontare criticamente i vari ambiti dell’insegnamento, da quelli più teorici a quelli più descrittivo-applicativi. Sono forniti numerosi esempi di domande oggetto delle prove d’esame, anche oggetto di discussione e commento durante le lezioni.
DOCENTE: S. PAGLIOLICO - L'apprendimento viene valutato attraverso un test scritto in aula, utilizzando il PC personale e la piattaforma di Ateneo "Exam". La prova scritta dura 1 ora ed è composta di 10-15 domande, a risposta aperta e chiusa, che vertono su aspetti culturali, scientifici e tecnologici rilevanti per la formazione. Alle domande a risposta chiusa viene assegnato un punteggio variabile da 1 a 3/30 a seconda della complessità/rilevanza della domanda. Alle domande che prevedono la possibilità di più risposte corrette viene assegnato un punteggio parziale positivo a ciascuna risposta corretta e un punteggio parziale negativo a ciascuna risposta errata. Alle domande aperte viene richiesta una risposta esaustiva e sintetica e assegnato un punteggio variabile da 3 a 5/30 a seconda della complessità/rilevanza della domanda. Il voto finale è dato dalla somma dei punteggi parziali totalizzati per ogni risposta. Un punto aggiuntivo è riservato alla chiarezza e al rigore espositivo delle risposte aperte e permette l’assegnazione della lode. Durante la prova scritta non è possibile consultare materiale di supporto. Il docente può chiedere delucidazioni sulle risposte (esprimere il processo logico) e/o una prova orale integrativa. I risultati dell'esame vengono pubblicati in Portale. Il test può essere visionato chiedendo appuntamento al docente. Numerosi esempi di domande d'esame vengono illustrati e commentati a lezione.
DOCENTE: D. JANNER - Prova scritta (a risposta aperta o chiusa). L’apprendimento dei contenuti dell'insegnamento da parte degli studenti sarà verificato tramite una prova scritta, della durata di 1h 45m, composta da dieci domande di tipo V/F che verteranno sugli aspetti culturali, scientifici e tecnologici di maggiore rilievo per lo studente di Architettura. Questa prima fase prevede una soglia di sbarramento che viene definita a seconda del compito e che comunque è superiore a 7/10 risposte esatte. Se la soglia di sbarramento non viene raggiunta l’esame non è superato e la seguente parte non verrà corretta. Per chi passasse lo sbarramento, seguiranno 6 domande aperte, a cui si richiede una risposta puntuale, articolata, esauriente ma nello stesso tempo sintetica, viene assegnato un punteggio massimo di 5/30 per ciascuna domanda; il voto finale sarà fornito dalla somma delle votazioni parziali conseguite per ciascuna domanda. In sede d’esame, allo studente sarà fornita la traccia, in cui a ciascuna domanda seguirà uno spazio congruo per lo svolgimento della risposta. Un facsimile della prova d’esame viene reso disponibile e commentato dal docente in aula.
Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
Exam: Written test; Computer-based written test in class using POLITO platform;
The learning and grading will be assessed through a written examination, which lasts 1.5 hours, consisting of ten questions related to the cultural, scientific and technological aspects which are more relevant for the Architectural students. For each question is required a precise, Comprehensive, even if concise response, to which may be assigned a maximum score of 3/30. The final grade will be provided by the sum of the partial scores obtained for each question. A test will be available and commented during the lessons.
Covid-19 emergency (lecturer Pagliolico): given the state of health emergency, the exam will be written with both open-ended and multiple choice questions from your pc by means of the University exam platform with proctoring tools (Respondus). A simulation of the exam is available on the portal in the section "Remote exams" and a fac simile of the written test is available in the section "Material". Exam questions will be similar to the ones asked in the previous academic years.
The student is asked to perform a simulation some days before the exam to check eventual criticalities and to solve them in time. Specifically, the following software and hardware requisites have to be satisfied: PC with a webcam and Windows 10 (adviced operating system for Respondus, that runs on Win 8 and 8.1 too; Win 7 is not recommended because it is no more supported by Microsoft; or Mac with a webcam and macOS 10.15-10.12, OS X 10.11, OS X 10.10).
Upon cessation of the state of health emergency, the "live" written test mode will be restored.
Covid-19 emergency (lecturer Montanaro): given the state of health emergency, the exam will be carried out as ORAL at least for the summer session, in accordance with the provisions of D.R. 217, 28/2/2020. The exam questions will be absolutely consistent with those used in the past, as can be seen from the facsimiles made available in the "Forum" section. Upon cessation of the state of health emergency, the written test mode will be restored with 10 open-ended questions.
In addition to the message sent by the online system, students with disabilities or Specific Learning Disorders (SLD) are invited to directly inform the professor in charge of the course about the special arrangements for the exam that have been agreed with the Special Needs Unit. The professor has to be informed at least one week before the beginning of the examination session in order to provide students with the most suitable arrangements for each specific type of exam.