Elenco notifiche

Caricamento in corso...
Pianificare la città (Atelier)
03RUUYT
A.A. 2025/26
Lingua dell'insegnamento
Italiano
Corsi di studio
Organizzazione dell'insegnamento
| Didattica | Ore |
|---|---|
| Lezioni | 12 |
| Esercitazioni in aula | 48 |
| Tutoraggio | 30 |
Docenti
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Frassoldati Francesca
Pianificare la città (Atelier) (Analisi e progettazione della morfologia urbana) |
Professore Associato | CEAR-09/A | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 |
|
Giaimo Carolina
Pianificare la città (Atelier) (Pianificazione locale) |
Professore Associato | CEAR-12/B | 12 | 48 | 0 | 0 | 6 |
|
Dell'Anna Federico
Pianificare la città (Atelier) (Valutazione e fattibilità economica) |
Professore Associato | CEAR-03/C | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 |
Collaboratori
Espandi
Riduci
Riduci
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biondi Francesca | Dottorando | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Nino Andrea | Dottorando | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Protti Emanuele | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Vitulano Valeria | Assegnista di Ricerca | 0 | 0 | 0 | 15 |
Didattica
| SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari |
|---|
2025/26
L’Atelier ha carattere multidisciplinare e abbraccia i temi della pianificazione e progettazione urbanistica, dell’amministrazione e gestione dei processi di pianificazione ed esplora le pratiche del “fare urbanistica” nelle sfide contemporanee della rigenerazione urbana, della transizione ecologica, della lotta alle disuguaglianze.
L'Atelier ha la finalità di sviluppare concretamente la conoscenza della natura e dei contenuti progettuali e normativi del piano urbanistico comunale, di fornire alcune tecniche di interpretazione e progettazione del piano urbanistico in un’ottica multidisciplinare e transcalare.
L’insegnamento e le attività sono incentrati sul caso studio del Comune capoluogo metropolitano e cioè sul piano urbanistico della Città di Torino (Piano Regolatore Generale-PRG, ex Lr 56/1977 e smi).
Gli studenti, simulando con i docenti l’attività complessa di un “Ufficio di piano” e i rapporti con i soggetti tecnico-politici, sociali ed economici del territorio, apprendono contenuti, struttura e modalità di predisposizione del progetto di PRG e, successivamente, attraverso un percorso di riflessione critica, riprogettano parte di esso motivando approcci, obbiettivi e scelte di contenuto (anche in tutto o in parte diverse dal PRG vigente), di fatto compiendo l’esperienza di redazione di una Variante generale di piano.
A fini didattico-esercitativi - posto che l’esercizio di pianificazione urbanistica riguarda l’intera città - si focalizzerà l’attenzione sul settore del territorio comunale situato a nord dell’asse viabile ottocentesco di Corso Regina Margherita, che attraversa la parte piana della città da est a ovest: dalle sponde del fiume Po (ai piedi della collina torinese) fino all'imbocco del sistema tangenziale torinese. Tale macro ambito urbano, esito di processi di crescita, modificazione e trasformazione innescati prima dallo sviluppo industriale novecentesco e poi dai fenomeni di ristrutturazione e riconversione economico-produttiva, presenta caratteri morfologico-insediativi, infrastrutturali, ambientali, paesaggistici e socio-economici assai complessi. Esso infatti è caratterizzato da una vasta gamma di “questioni urbanistiche” che chiedono di essere affrontate entro una strategia di rigenerazione urbano-territoriale complessa: dalle significative aree ancora dismesse (industriali, ferroviarie, terziario-direzionali) in attesa di una rifunzionalizzazione, agli estesi parchi fluviali urbani e territoriali non ancora attuati, alla ristrutturazione, anche molto puntuale, dei tessuti edificati esistenti, al potenziamento e riforma delle linee di forza della mobilità su ferro.
The Atelier has a multidisciplinary character and embraces the topics of urban planning, management of planning processes and explores the practices of making and designing the city as well as the challenges of urban regeneration of the contemporary city.
The Atelier aims to concretely develop the knowledge of the nature, the planning and regulatory contents of the municipal urban plan, providing some analytical techniques and design tools for the urban plan in a multidisciplinary and transcalar perspective. The Atelier is focused on a case study of a metropolitan municipality and, specifically, on the urban plan of the City of Turin (General Municipal Plan-GMP,under Regional Law 56/1977 56/1977 and subsequent amendments).
The students, almost simulating with the tutors the complex activity of a "planning office" and the relations with the social, political and economic aspects of the territory, learn the contents and structure of the GMP project. Subsequently, through a path of critical reflection, they could redesign part of it by motivating the choices of approaches, objectives (also in whole or in part different from the Turin GMP), effectively carrying out the experience of drafting a GMP Amendment..
The urban planning exercise concerns the entire city. However, for educational-exercise purposes, we will focus our attention on the sector of the municipal territory located north of the important 19th-century road axis of Corso Regina Margherita, which crosses the flat part of the city from east to west: from the banks of the river Po (at the foot of the Turin hill) to the entrance of the Turin ring road system. This urban macro-area, the result of growth, modification and transformation triggered first by 20th-century industrial development and then by the phenomena of economic-productive restructuring and reconversion, presents very complex morphological-settlement, environmental, landscape, infrastructural and socio-economic characteristics. It is characterised by a wide range of urban issues that need to be addressed within an urban regeneration strategy: from the significant disused areas (industrial, railway, tertiary) awaiting re-functionalisation to the extensive urban and territorial river parks that have not yet been implemented, to the completion, even very punctual, of the existing built fabric, the strengthening and reform of the main rail transport corridors.
.
Al termine dell’Atelier (14 settimane didattiche) gli studenti saranno in grado di:
Conoscere e comprendere natura, contenuti, efficacia del piano urbanistico comunale in Italia.
Comprendere il ruolo del piano nella definizione di strategie per la sostenibilità.
Conoscere gli strumenti concettuali per comprendere la complessità dei fenomeni spaziali (urbani e territoriali) e dei processi che ne hanno determinato struttura e caratteristiche qualitative e quantitative.
Conoscere e sperimentare pratiche di indagine e interpretazione urbanistica, rappresentazione delle caratteristiche spaziali, morfologiche e determinanti del progetto.
Conoscere pratiche innovative per la redazione del piano urbanistico locale e sviluppare capacità per applicarle nel percorso progettuale.
Conoscere tecniche e approcci per analizzare e progettare, nel piano urbanistico, aspetti morfologico-insediativi e infrastrutturali, economici e sociali, edilizi e ambientali, paesistici, storici e culturali della città.
Avere la capacità di sviluppare un pensiero critico attorno alla costruzione di possibili scenari di trasformazione urbanistica.
Avere la capacità di valutare gli esiti morfologici delle scelte di piano e di esprimere linee per la progettazione della sua attuazione.
Avere la capacità di impostare valutazioni di sostenibilità e di analizzare la fattibilità economica delle trasformazioni urbane proposte nella redazione del piano urbanistico comunale.
- Knowledge and understanding of the nature, contents and effectiveness of the municipal urban plan in Italy;
- Understanding the role of the plan in defining strategies for sustainability.
- Knowledge of conceptual tools to understand the complexity of spatial phenomena (urban and territorial) and the processes that have determined their structure and qualitative and quantitative aspects.
- Knowledge and experimentation of urban research practices, representation of the spatial, morphological and determining characteristics of the project;
- Knowledge of innovative and experimental practices in the preparation of the local urban plan and the ability to apply them in the design process.
- Knowledge of techniques and approaches to analyse and plan, the urban plan, the settlement and the infrastructural, physical and environmental landscape as well as the historical and cultural, economic and social aspects of the city and its territory.
- Ability to develop critical thinking around the construction of possible urban transformation scenarios.
- Ability to evaluate the morphological results of the plan and to define guidelines for its implementation.
- Ability to set sustainability assessments and analyse the economic feasibility of urban transformations proposed in the drafting of the municipal urban plan.
Capacità di lavorare in gruppo, gestendo diversi contributi disciplinari.
Capacità di raccogliere e selezionare informazioni sulle aree del caso studio, rappresentare dati, informazioni, percezioni con diversi strumenti e modalità.
Capacità individuale di disegnare con varie tecniche e strumenti GIS, concentrandosi su una serie di obiettivi e scale di comunicazione.
Conoscenze di base relative a tecniche di pianificazione e progettazione urbanistica acquisite attraverso corsi e studi di primo livello.
Conoscenze di base della legislazione urbanistica nazionale e regionale piemontese.
Conoscenza della struttura e articolazione del sistema italiano di pianificazione e governo del territorio.
- Ability to work in a team, managing various disciplinary contributions.
- Ability to collect and select information on the case study area, represent data, information, perceptions with different tools and methods.
- Ability to draw with various techniques, focusing on a series of objectives and scales.
- Basic knowledge of planning and urban design techniques acquired through previous courses and studies.
- Basic knowledge of state and regional town planning legislation
- Knowledge of the structure and articulation of the Italian territorial planning and governance system.
L’Atelier adotta un approccio multidisciplinare al tema della pianificazione urbanistica comunale e si sviluppa su 12 Crediti Formativi Universitari (CFU) fra loro fortemente relazionati:
6 CFU di Pianificazione e progettazione urbanistica (CEAR-12/B),
3 CFU di Analisi e progettazione della morfologia urbana (CEAR-09/A),
3 CFU di Valutazione e fattibilità economica (CEAR-03/C).
L’Atelier si svolge nel 2° PD ed è incentrato sul caso studio costituito dal PRG della Città di Torino vigente dal 1995 e sulle relazioni che intrattiene con la conurbazione metropolitana. Un territorio caratterizzato da rilevanti dinamiche trasformative sia nel passato, sia nel corso degli ultimi decenni, ricco di risorse naturali, paesistiche, storico-culturali, oggetto, in anni recenti, di una articolata attività di revisione del PRG il cui iter amministrativo ha preso avvio il 20 agosto 2020 (con la passata amministrazione comunale) e, sul piano procedurale, si è fermato con la conclusione della 1° Conferenza di copianificazione e valutazione (dicembre 2020). Dal 2023 sono ripresi i lavori per la redazione del Progetto preliminare di PRG.
L’Atelier coglie questa situazione come opportunità per entrare nel vivo del processo di revisione sia dal punto di vista tecnico, sia per testare le sfide della complessità (ambientali, economiche, sociali) e della multidimensionalità delle trasformazioni urbane, delle loro relazioni con strumenti di gestione, con bisogni, desideri e visioni dei diversi soggetti sociali.
L’Atelier è dunque finalizzato a formulare delle proposte di revisione urbanistica, mettendo in tensione modificazioni/trasformazioni urbane, cambiamenti sociali e alterazioni ambientali: il piano urbanistico generale viene assunto come strumento utile e necessario per il governo della città in quanto telaio di riferimento per individuare priorità, indirizzare, coordinare e guidare l’organizzazione dello spazio.
1) MODULO PIANIFICAZIONE LOCALE (6 CFU) CEAR-12/B
Il Modulo "Pianificazione locale" muove dal riconoscimento del radicale mutamento di paradigma che caratterizza oggi il “fare urbanistica”: il venir meno del nesso fra urbanistica e crescita. L’urbanistica dell’espansione quantitativa e dello sviluppo economico lineare è terminata da tempo: la crescita ininterrotta dell'urbanizzato è andata progressivamente arrestandosi e si moltiplicano le situazioni di contrazione, dismissione e abbandono. Nello stesso tempo sono sempre più evidenti la gravità delle condizioni economico-sociali e ambientali complessive, le conseguenze dei cambiamenti climatici e la centralità che la questione ecologica dovrebbe assumere nelle scelte di governo del territorio, così come sono evidenti i limiti della pianificazione della regolazione dell’uso del suolo tradizionalmente intesa.
Il Modulo "Pianificazione locale" tratta i temi della pianificazione e progettazione urbanistica, della gestione dei processi di pianificazione e propone metodologie innovative del “fare urbanistica”: sviluppando concretamente la conoscenza della natura, dei contenuti progettuali e normativi del piano urbanistico comunale, fornendo alcune tecniche e metodologie di strutturazione innovativa del piano, basate sul principio di coerenza.
Il Modulo, in coordinamento con gli altri due, si articola in tre parti.
La prima: circa 3 settimane, richiama caratteristiche e impianto progettuale dei piani novecenteschi di Torino (1908-1995), riprende contenuti fondamentali della tecnica urbanistica ex Lr 56/1977 e smi (funzioni urbane, dimensionamento, peso insediativo, carico urbanistico).
La seconda: circa 5 settimane, introduce l’ambito del caso-studio oggetto di sperimentazione progettuale, definendo e praticando diverse metodologie e approcci alla conoscenza (inclusi sopralluoghi sul campo) e alla interpretazione strutturale della città, con particolare riferimento al sistema insediativo e infrastrutturale. Affronta i problemi contemporanei di pianificazione e progettazione urbanistica relativi a vivibilità e benessere, mobilità, sostenibilità e transizione green e quelli connessi al processo di pianificazione generale (natura, contenuti, elaborati e procedure del PRG nella Lr 56/1977 e smi). Infine, applica al caso Torino proposte metodologiche e operative per l’innovazione del piano urbanistico comunale, del progetto di suolo e dei suoi paradigmi.
La terza: circa 6 settimane, è dedicata al lavoro di pianificazione e progettazione urbanistica sull’area oggetto di sperimentazione, facendo uso delle metodologie acquisite per la redazione di una proposta di Variante urbanistica generale di PRG da parte di ogni Gruppo di studenti. Tale proposta di Variante è sviluppata negli Elaborati che comporranno il “Dossier finale di Atelier”, che comprende gli Elaborati anche degli altri due Moduli.
2) MODULO ANALISI E PROGETTAZIONE DELLA MORFOLOGIA URBANA (3 CFU) CEAR-09/A
Ripensando il piano urbanistico per una città in trasformazione, la comprensione integrata delle forme urbane e degli impianti edilizi è strumentale a formulare delle ipotesi realistiche e a capire gli impatti delle decisioni pubbliche.
Il modulo di Analisi e Progettazione della Morfologia Urbana si propone di fornire una cornice di riferimento per leggere le forme urbane rispetto al dibattito contemporaneo, elaborare indicazioni progettuali e collegare il governo dei processi di trasformazione alle forme costruite.
Leggeremo la città di Torino a partire dagli elementi costruiti e dagli spazi pubblici, riconoscendone la storia urbana attraverso le strutture e le infrastrutture fisiche, ricostruendo attitudini ricorrenti nei progetti per specifiche condizioni urbane, costruendo una libreria condivisa - che da Torino spazia verso altre città europee - in modo da ipotizzare possibili modalità di sviluppo operativo del Piano urbanistico.
Seguendo la scansione coordinata tra le tre discipline, il contributo di Analisi e Progettazione della Morfologia Urbana si articolerà in tre momenti:
nel primo (circa 3 settimane), lavoreremo sulla lettura delle forme urbane che si incontrano nella città di Torino, evidenziando le condizioni per il progetto della città contemporanea; nel secondo momento (5 settimane circa) costruiremo una libreria condivisa di riferimenti progettuali utili per la terza parte (6 settimane circa) di formulazione di indirizzi morfologici funzionali alle proposte del Modulo di Pianificazione Locale (integrazione del progetto urbano come strumentale alle decisioni di piano).
Il modulo ha un approccio fortemente operativo. Lezioni, esercitazioni, dialoghi e sopralluoghi hanno sempre un'applicazione concreta e sperimentale, al fine di poter meglio vedere gli spazi che produciamo e toccare con mano le trasformazioni possibili.
3) MODULO VALUTAZIONE E FATTIBILITÀ ECONOMICA (3 CREDITI) CEAR-03/C:
Il Modulo fornisce competenze per analizzare gli aspetti economico-finanziari della pianificazione urbanistica e valutare la fattibilità delle trasformazioni urbane. Gli studenti apprendono strumenti specialistici per supportare le decisioni pianificatorie attraverso analisi economiche integrate.
Il Modulo si propone di sviluppare negli studenti competenze per condurre analisi valutative nella fase conoscitiva preliminare della pianificazione ed elaborare progetti urbanistici controllando gli impatti economico-finanziari e le interazioni con le dinamiche di mercato. Gli studenti acquisiranno inoltre capacità di applicare strumenti valutativi specifici per interventi di iniziativa privata, pubblica e partenariato pubblico-privato, supportando le verifiche di fattibilità progettuale nell'iter di formazione dei piani urbanistici e orientando le decisioni di investimento in programmi e progetti complessi di rigenerazione urbana e territoriale.
Nella prima fase del percorso didattico (settimane 1-4) vengono illustrati gli strumenti metodologici per l'analisi del contesto territoriale ed economico, compresi i metodi di analisi SWOT e le tecniche di valutazione preliminare delle opportunità e criticità. Gli studenti acquisiscono competenze per interpretare le dinamiche socio-economiche e ambientali del territorio, con particolare riferimento al caso-studio dell'Atelier.
Nella seconda fase (settimane 5-8) si applicano al PRG della Città di Torino gli strumenti analitici per orientare le scelte progettuali, con focus sulle verifiche di fattibilità finanziaria ed economica attraverso Analisi Costi-Ricavi e Analisi Costi-Benefici. Particolare attenzione è dedicata alla valutazione degli impatti ambientali sui sistemi urbani e territoriali.
Nella terza fase (settimane 9-14), di carattere operativo, i gruppi di lavoro sviluppano valutazioni economiche delle proprie proposte progettuali, utilizzando in modalità simulativa gli strumenti precedentemente illustrati. A partire dalle ipotesi di Variante di Piano elaborate, gli studenti dovranno valutare la sostenibilità economica delle proposte progettuali, ricalibrando eventualmente i progetti in funzione della loro fattibilità e identificando condizioni, risorse e soggetti necessari per l'attuazione degli interventi.
I risultati del lavoro saranno restituiti attraverso tavole grafiche e relazioni di sintesi, strutturate secondo le componenti di uno Studio di Fattibilità, che costituiranno parte integrante del Dossier finale di Atelier.
The Atelier is spread over 12 highly related university training credits:
- 6 CFU of Planning and urban planning (Icar 21),
- 3 CFU of Analysis and design of urban morphology (Icar 14)
- 3 Evaluation and economic feasibility credits (Icar 22),
The Atelier takes place in the 1st PD and focuses on the case study of the current municipal general plan of the City of Turin and on the relationships, it has with its metropolitan area. A territory that is characterized by significant transformative dynamics both in the past and in the last decades, rich in natural, landscape, historical-cultural resources and today subject to an articulated revision of the current PRG. This case study is used as an opportunity to reflect and investigate on the the complex and multidimensional challenges of urban transformations, their relationships with management systems, with the needs, desires and visions of different actors, with the challenge of sustainability (and the "value" of natural resources) and of course social justice.
The Atelier is therefore aimed at formulating proposals for modification to the current PRG by reflecting contextually on urban modifications / transformations, social changes and environmental alterations.
It starts from the assumption that the general urban plan should act as a reference to guide possible transformations, assuming different contents and dimensions to respond to the complex challenges that the contemporary city is facing.
1. Modulo Pianificazione locale, (6 crediti) ICAR 21:
The Module is divided into three parts.
The first, for about 4 weeks, traces the events and contents of Turin's urban developments over time (1908-1995), it examines the relationship between Turin and the regional and provincial planning (Territorial and Landscape Plan of Piedmont Region; Territorial Coordination Plan of the Province of Turin; Strategic Plan and the PTGM of the Metropolitan City of Turin) and introduces the case study and the objectives of the (Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino (PSRI) and its urban surroundings). This is done with different methodologies and approaches to knowledge (including site visits conducted virtually or in the actual territory according to the medical disposition).
The second, for about 2 weeks, deals with contemporary urban planning and planning problems (liveability and well-being, mobility, sustainability; general planning process: nature, content, documents and procedures of the PRG in the Piedmont urban planning law); presents and discusses some good examples and practices as references that have dealt with the urban project and its paradigms.
The third, for about 8 weeks, is dedicated to planning and design of the selected, aimed at the preparation of a Variante (strutturale o parziale del Prg)by each group of students and which will form the basis of the "Final Dossier Atelier”(which also includes the works of the other two Modules in an interrelated way).
2. Modulo Analisi e progettazione della morfologia urbana, (3 crediti) ICAR 14:
This module focuses on offering a critical approach to strategic planning and urban design adopting multidisciplinary socio-spatial strategies both in form and processes. It is developed in the context of a debate on urban regeneration in its tensions between gentrification and inclusion and social justice. It Reflects on the different knowledge of the spatial and urban project, of volumetric representations of socio-spatial strategies, of mapping and representation of the project. It does provide an opportunity for debating socio-spatial strategies for the urban project, urban regeneration and transformation policies.
The contribution aims to develop an urban design project by defining socio-spatial strategies and possible spatial morphologies by elaborating a series of compositional exercises (mapping, narrations, diagrams, principles, strategies and spatial interventions cantered on the theme of infrastructure of care and thinking holistically about the system of spaces, devices, relationships that allow / guarantee a decent level of livability.
The contribution focuses on a socio-spatial idea of infrastructure and not technical understanding of it but better in the performative sense, that is, focusing attention on the making and unmaking of infrastructures. This is in order to conceive their role in structuring asymmetric relationships of vulnerability and privilege, trying to understand in concrete terms what it means to produce environmental conditions that sustain life. This interdisciplinary angle represents an opportunity to reflect on care as maintenance, as support and as maintenance, repair by introducing references from uncritical, feminist and black studies literature, focusing on vulnerability, production, security, reproduction, knowledge, affectivity as a discourse around new and better conditions for living, security, access and inclusion in services.
3. Modulo Valutazione e fattibilità economica, (3 crediti) ICAR 22:
The Evaluation and Economic Feasibility credits focus on the economic and financial aspects linked to the plan. The aim is to provide specialist analytic tools, highlighting the role and operational consequences of the evaluation and estimation techniques learned, in part, in the three-year degrees, obviously recontextualising and deepening them.
In particular, the course aims to provide students with tools for:
- contributing to the drafting of urban planning projects by controlling its effects on the economic-financial level and the relations with markets;
- carrying out evaluation activities with specific tools and with reference to private, public and public-private interventions;
- assisting with the feasibility checks of the projects, during the production of urban plans;
- supporting investment decisions in the context of complex urban and territorial redevelopment programs and projects.
In the first part of the course, some sessions will be dedicated to briefly recalling concepts and related tools useful for dealing with specific aspects of the articulation of economic reasoning and offering some concrete examples - with reference to Atelier’s case study area- including: the real estate development process from a public and private point of view; the concept of profit, extra-profit, urban rent; equalization and systems of real estate values objectified by the market; elements of risk and uncertainty analysis in real estate investments; etc. At the same time, aspects of an estimative nature will be recalled, useful to clarify the proposed topics.
Subsequently, we will start to think about the municipal general regulatory plan of the City of Turin, identifying the analysis tools useful for defining the project choices, with particular attention to financial and economic feasibility checks, typically through the Cost, Revenue and Benefit Cost Analysis. In addition to the economic repercussions, knowledge of the environmental repercussions on urban and territorial systems is considered important for the training of students.
In the second part – more operative - the students, organized in working groups, will be called upon to produce their own economic reasoning, accompanied and supported by the simulation application of the assessment tools previously identified.
In particular, starting from the project hypotheses of the Variante di Piano, they will have to evaluate the economic feasibility of their projects, possibly redefining them according to their actual practicability and identifying the conditions and subjects to be involved in making them feasible.
The results achieved must be represented in tables and summary reports, according to a scheme attributable to parts of a Feasibility Study relating to their project.

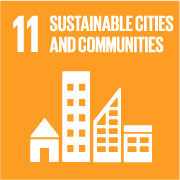
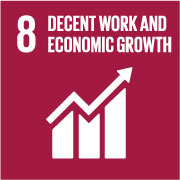

Nessuna
Nessuna
L'attività didattica è svolta con il supporto di lezioni frontali e seminari, sopralluoghi didattici, attività esercitative - e revisioni - svolte dagli studenti (in aula o con lavoro sul campo dell’area di studio) organizzati in piccoli gruppi, volte a predisporre lavori intermedi (o specifici) dei diversi contributi disciplinari e il “Dossier finale di Atelier”, finalizzato a presentare e discutere (secondo modalità più precisamente definite dalla docenza nella fase iniziale dell’Atelier) gli Elaborati finali dei tre Moduli e a verificare e a consolidare le conoscenze progressivamente acquisite.
L’attività di apprendimento prevede l’applicazione di abilità di analisi sul campo e su supporto cartografico, la lettura di testi e la visione di video, la discussione e il confronto interno al gruppo e con esperti, la pratica di abilità interpretative, la produzione di testi scritti (relazioni) ed elaborazioni cartografiche.
L’attività di apprendimento si applica al caso studio ed è tesa a verificare le tesi e le metodologie disciplinari che vengono presentate durante alcune lezioni in aula, su materiali documentari preesistenti e su informazioni ricavate direttamente da visite e sopraluoghi sul campo, per poi restituirle in elaborazioni (scritte, cartografiche, fotografiche, ecc.) in base alle indicazioni fornite dai docenti.
Gli Elaborati (grafici e scritti) del “Dossier finale di Atelier” sono da redigere preferibilmente in formato digitale ma devono in ogni caso essere consegnati anche in formato immagine (pdf).
In linea generale, per lo sviluppo dell’Atelier si prevede di dedicare in complesso circa il 40% del tempo alla presentazione di tematiche e metodologie e alla elaborazione della parte analitica; circa il 60% del tempo alla elaborazione della parte di interpretazione e sintesi per il progetto di piano.
Le attività svolte saranno monitorate attraverso alcuni momenti di verifica dell’apprendimento, sia a carattere monodisciplinare, sia seminariale (ovvero con la partecipazione di tutte le discipline) che consistono nella presentazione e discussione orale, supportata da elaborazioni grafiche, delle bozze di alcuni elaborati del “Dossier finale di Atelier”.
I momenti di verifica dell’apprendimento delle attività condotte dai tre Moduli dell’Atelier concorreranno al giudizio finale, basato sulla presentazione e discussione degli Elaborati (scritti e grafici) raccolti nel “Dossier finale di Atelier”.
L’Atelier ha carattere multidisciplinare e richiede una assidua frequenza di tutti i Moduli di cui si compone, anche in considerazione del giudizio finale che sarà espresso con un unico voto d'esame (in trentesimi), cui le diverse discipline concorrono proporzionalmente al loro peso in termini di CFU.
Va tenuto presente che il totale dei Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti per il presente insegnamento misura la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dal programma del presente insegnamento. Un credito (1 CFU) corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo che comprende lezioni, esercitazioni, etc., ma anche lo studio individuale. Pertanto, poiché l’Atelier ha un valore complessivo di 12 CFU, richiederà un impegno di 300 ore (ovvero 25 ore/CFU x 12 CFU), delle quali 140 saranno dedicate alla didattica erogativa (lezioni, esercitazioni, attività in aula) e le restanti 160 allo studio individuale e/o di gruppo che studentesse e studenti dovranno svolgere in autonomia.
The activity of the module is carried out with the support of lectures and seminars, filed visits , practical activities - and tutorials - carried out by the students (in the classroom or in the study area) organized in small groups. Such series of activities is aimed at preparing a number of different intermediate outputs of the various disciplinary contributions and the "Atelier Final Dossier", aimed at presenting and discussing (according to procedures more precisely defined by the tutors in the initial phase of the Atelier) the prepared documents and to verify and consolidate the knowledge of the area and its transformation, gradually acquired.
The learning activity involves the application of analytics skills, mapping tools and development of cartographic support, the reading of texts and the viewing of videos, the discussion with experts, the practice of interpretative skills, the production of written texts (Reports) and cartographic elaborations. The learning activity is applied to the case study and is aimed at verifying the theses and disciplinary methodologies that are presented during some lectures in the classroom, on pre-existing documentary materials and on information obtained directly from field visits and inspections, and then producing comprehensive outcomes(written, cartographic, photographic, etc.) based on the indications provided.
The works (graphics and writings) are to be produced in digital format and must be delivered in pdf. In general, for the Atelier it is expected to spend a total of 30% of the time on the presentation of the issues and methodologies and on the elaboration of the analytical part; about 70% of the time to the elaboration of the project and its synthetic outcome.
I testi, scelti tra quelli elencati ed altri eventuali, saranno inoltre comunicati durante le lezioni dal docente titolare dell’insegnamento di ogni Modulo.
PIANIFICAZIONE LOCALE
Barbieri C.A. (2005), “I territori del piano”, Urbanistica n. 127, pp. 46-53.
Gabellini P. (2010), Fare urbanistica. Esperienze, comunicazione, memoria, Carocci Editore, Roma.
Gabellini P. (2018), Le mutazioni dell'urbanistica. Principi, tecniche, competenze, Carocci Editore, Roma.
Gabellini P. (2024), Avvicinarsi all’urbanistica | Approaching Urbanism, Planum Publisher, Roma-Milano, http://www.planum.bedita.net/planum-magazine/planum-publisher-publication/avvicinarsi-all-urbanistica-approaching-urbanism-gabellini-2024.
Galuzzi P., Vitillo P.G. (2011), Praticare il piano?, Inu Edizioni, Roma.
Giaimo C. (2024), “Urbanistica Open science. Il piano come infrastruttura democratica e sostenibile”, Urbanistica Informazioni n. 317, p.4-6.
Giaimo C. (a cura di) (2020), “Tra spazio pubblico e rigenerazione urbana. Il verde come infrastruttura per la città contemporanea”, urbanistica Dossier online n. 17, http://www.inuedizioni.com/it/prodotti/rivista/n-017-urbanistica-dossier.
Giaimo C. (2021), “(Ri) comporre relazioni. Le dotazioni urbanistiche”, in F.D. Moccia e M. Sepe (a cura di), Benessere e salute delle città contemporanee, INU Edizioni, Roma, pp. 271-278.
Pasqui G. (2017), Urbanistica oggi. Piccolo lessico critico", Donzelli, Roma.
ANALISI E PROGETTAZIONE DELLA MORFOLOGIA URBANA
--E. Ben-Joseph, 2005. The Code of the City. Standards and the Hidden Language of Place Making, MIT Press, Cambridge Mass.
-S. Boeri, A. Lanzani, E. Marini, Il territorio che cambia. Ambienti, paesaggi e immagini della regione milanese, Abitare-Segesta, Milano 1993
-S. Boeri, L'anticittà, Laterza, Roma-Bari, 2011
P. A. Fernandez, J. Mozas, 2017. Complex Buildings. Dwelling Mixer. A+U, n.49. -P. A. Fernandez, J. Mozas, 2022. Generosity. The Indeterminacy of the Floor Plan. A+U, n.56
-Y. Friedman, L'architecture mobile: vers une cité conçue par ses habitants, Casterman, Paris, 1970
-J. Jacobs, Vita e morte delle grandi città, Einaudi, Torino, 1969
-R. Koolhaas, Junkspace, Quodlibet, Macerata 2006.
-R. Koolhaas, Ritratto di una metropoli Potemkin ... o trent'anni di tabula rasa, Quodlibet, Macerata, 2010.
A. Lenherer, 2009. Grand Urban Rules. Rotterdam: nai010.
-K. Lynch, L’immagine della città, Marsilio, Venezia 2008 (1964) (ed. originale: The Image of the City, The M.I.T. Press, Cambridge, Mass. 1960).
-T. Maldonado, La speranza progettuale, Einaudi, Torino, 1971.
-N. Portas, Arquitectura(s). Teoria Desenho, Investigacão e Projecto, FAUP, Porto, 2005.
-A. Rossi, Scritti scelti sull'architettura e la città 1956-1972, Quodlibet, Macerata 2012.
-A. Rossi, L’architettura della città, Marsilio, Padova, 1966.
-B. Secchi, La città del ventesimo secolo, Laterza, Roma-Bari, 2005.
-B. Secchi, Prima Lezione di Urbanistica, Laterza, Roma-Bari, 2000.
-D. Sim, 2019. Soft City: Building Density for Everyday Life, Washington: Island Press.
–C. Waldhenim, 2016. Landscape as Urbanism. Princeton: Princeton University Press
-R. Venturi, D. Scott Brown, S. Izenour, Imparando da Las Vegas, Cluva, Venezia 1985 (Learning From Las Vegas, The M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1972).
VALUTAZIONE E FATTIBILITÀ ECONOMICA
Berta M., Bottero M., Dell'Anna F., Morgese V. (2024), "An Integrated Framework to Support Adaptive Reuse Urban Design: a Case Study in the City of Taranto (Italy)", GEAM. Geoingegneria Ambientale e Mineraria n. 171, pp. 1121-9041.
Bottero M., Mondini G. (2009), Valutazione e sostenibilità. Piani, programmi, progetti, Celid, Torino.
Bravi M., Fregonara E. (2004), Promozione e sviluppo immobiliare. Analisi dei processi e tecniche di valutazione, Celid, Torino.
Hill T., Westbrook R. (1997), "SWOT analysis: It's time for a product recall", Long Range Planning n. 30(1), pp. 46-52.
Prizzon F. (2001), Gli investimenti immobiliari. Analisi di mercato e valutazione economico-finanziaria degli investimenti, Celid, Torino.
Roscelli R. (a cura di) (2014), Manuale di estimo, UTET Università, Novara.
Stanghellini S. (2013), Perequazione, compensazione, fattibilità, INU Edizioni, Roma.
Wheelen T.L., Hunger J.D. (1995), Strategic Management and Business Policy, 5th Edition, Addison Wesley, Reading, MA.
A preliminary list is provided below. will also be communicated during the sessions.
Barbieri C.A. (2005), “I territori del piano”, Urbanistica n. 127, pp. 46-53.
Campos Venuti G. (2012), Amministrare l’urbanistica oggi, INU Edizioni, Roma.
Galuzzi P., Vitillo P.G. (2011), Praticare il Piano?, INU Edizioni, Roma.
Gabellini P. (2010), Fare urbansitica. Esperienze, comunicazione, memoria, Carocci Editore, Roma.
Giaimo C. (a cura di), 2019, Dopo 50 anni di standard urbanistici in Italia. Verso percorsi di riforma; INU Edizioni, Roma. [testo in vendita in formato digitale]
Giaimo C., Barbieri C. A., Salata S. (2019), “Ecosystem Services Based Approach for Participatory Spatial Planning and Risk Management in a Multi-Level Governance System”, In: G. Brunetta, C. Caldarice, N. Tollin, J. Moratò (eds.), Urban Resilience for Risk and Adaptation Governance, Theory and Practice, Springer, Cham, p. 59-74, https://doi.org/10.1007/978-3-319-76944-8_5
Pasqui G. (2017), Urbanistica oggi. Piccolo lessico critico", Donzelli, Roma.
Bianchetti, C. (2016) Spazi che contano. Il progetto urbanistico in epoca neo-liberale, Donzelli Roma.
Meschiari, M. (2019), “Neogenografia”, in id., Neogeografia. Per un nuovo immaginario terrestre, Milieu Edizioni, Milano, pp. 9-36.
De Matteis, A., (2018), Architettura e realtà. Crisi e orizzonti del progetto contemporaneo. Quodlibet, Macerata.
Bottero, M., Mondini, G., 2009, Valutazione e sostenibilità. Piani, programmi, progetti, Celid, Torino.
Bravi, M., Fregonara, E., 2004, Promozione e sviluppo immobiliare. Analisi dei processi e tecniche di valutazione, Celid, Torino.
Prizzon F., 2001, Gli investimenti immobiliari. Analisi di mercato e valutazione economico-finanziaria degli investimenti, Celid, Torino.
Roscelli R. (a cura di), 2014, Manuale di estimo, UTET Università, Novara.
Stanghellini S., 2013, Perequazione, compensazione, fattibilità, INU Edizioni, Roma.
Slides; Dispense;
Lecture slides; Lecture notes;
Modalità di esame: Prova orale obbligatoria; Elaborato grafico prodotto in gruppo; Elaborato scritto prodotto in gruppo; Elaborato progettuale in gruppo;
Exam: Compulsory oral exam; Group graphic design project; Group essay; Group project;
...
In fase di avvio dell’insegnamento, nel corso della prima lezione, sarà svolta, congiuntamente dai tre docenti, una comunicazione in aula per illustrare le modalità di verifica dell’apprendimento per il superamento dell’esame finale, come di seguito descritto.
L'esame finale mira a verificare l'acquisizione delle conoscenze e delle capacità descritte nel campo “Risultati di apprendimento attesi” tramite un’unica Prova orale obbligatoria la cui discussione verte attorno alla presentazione degli Elaborati (relazioni e tavole) che compongono il “Dossier finale di Atelier” (prodotti dagli studenti accorpati in gruppi di massimo 3 persone) che contengono la Variante generale al PRG vigente di Torino sull’area di studio, sviluppato da ogni gruppo.
In particolare si prevede di discutere:
• il progetto urbanistico in termini di contenuti e impianto normativo e di rapporto con la forma dello strumento;
• gli esiti morfologici delle strategie socio-spaziali definite dalla Variante generale di piano e le linee guida per la progettazione della sua attuazione;
• la fattibilità economica delle trasformazioni urbane proposte.
Necessario al superamento dell’esame è un corretto utilizzo della terminologia e una chiara e sintetica esposizione che illustri i collegamenti logici tra gli aspetti considerati.
Gli Elaborati del “Dossier finale di Atelier” vengono consegnati (tramite caricamento nella pagina Elaborati del Portale della didattica) 3 giorni prima dello svolgimento dell’esame.
L’Atelier richiede una assidua frequenza di tutti i Moduli di cui si compone, anche in considerazione del giudizio finale che sarà espresso con un unico voto d'esame (in trentesimi), cui le diverse discipline che caratterizzano ogni Modulo concorrono proporzionalmente al loro peso in termini di CFU.
La valutazione avverrà:
- per il 40% rispetto alle revisioni e discussioni del progetto in itinere;
- per il 60% rispetto alla discussione finale degli elaborati di progetto.
Gli elementi per la valutazione della performance individuale sono: frequenza; partecipazione attiva al lavoro di gruppo e revisioni; conoscenza del lavoro del gruppo; conoscenza degli argomenti dell’Atelier (lezioni frontali e contenuti di riferimenti bibliografici).
Tra gli elementi di valutazione vi sarà la capacità di rispettare l’organizzazione delle attività di Atelier.
Si tenga conto che l’insufficienza anche in uno solo dei tre Moduli non consente di superare l’Atelier.
Anche se le attività di Atelier sono svolte dagli studenti accorpati in gruppi, il giudizio per ciascuno studente sarà un giudizio individuale (espresso con unico voto), che terrà conto delle verifiche di apprendimento intermedie (scritte, orali, grafiche) monodisciplinari e seminariali, della valutazione della presentazione e discussione degli Elaborati finali d’esame e della partecipazione individuale a tale lavoro e ai momenti di presentazione.
Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
Exam: Compulsory oral exam; Group graphic design project; Group essay; Group project;
Presentation by the small groups formed during the Atelier (gathered in a single Dossier of Variante to the Municipal Urban Plan of the case study of the Atelier), of the prepared works (written reports, drawings, graphic drawings, Ppt presentation, etc.) and oral examination.
The individual vote will be referred to the totality of the work and will constitute a synthesis of the opinion of the three professors.
In addition to the message sent by the online system, students with disabilities or Specific Learning Disorders (SLD) are invited to directly inform the professor in charge of the course about the special arrangements for the exam that have been agreed with the Special Needs Unit. The professor has to be informed at least one week before the beginning of the examination session in order to provide students with the most suitable arrangements for each specific type of exam.